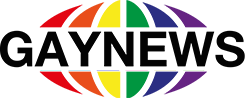Nel 2011 il critico cinematografico Roger Ebert ha definito Terrence Frederick Malick «uno dei pochi registi i cui film non sono mai meno che capolavori» e anche in questo caso il maestro dell’Illinois, già vincitore della Palma d’Oro a Cannes per The tree of life e dell’Orso d’Oro a Berlino per The Thin Red Line, non si smentisce.
Song to Song, lavoro dalla marcata cifra estetica ed estatica, riesce nell’impresa di affascinare e incantare lo spettatore per tutta la durata della pellicola. Il film, che racconta la storia di un duplice triangolo sentimentale, a metà strada tra Closer e Jules et Jim, caratterizzato da forme d’amore violento, esasperato, a sessi alternati e non, s’interroga sul senso della nostra esistenza e ci ricorda perentoriamente che nulla è come sembra, servendosi di una struttura narrativa claustrofobica, con ripetute riprese in soggettiva, pochissimi dialoghi e frequenti ricorsi a voli di uccelli, metafora di libertà e di ricongiungimento con l’universo.
«Volevo qualcosa di vero. Nulla sembrava vero» dice Faye, la protagonista del film, interpretata da Rooney Mara e da questa dichiarazione consegue la rincorsa ossessiva dei personaggi all’esperienza immediata, al godimento, alla verità della sensazione corporea come uniche forme di realtà. D’altronde, questa è una delle grandi proposizioni ideologiche del contemporaneo, di un mondo che, come direbbe Alain Badiou, pare essere formato solo da corpi e linguaggio. E l’idea secondo cui – sempre per usare le parole della protagonista – «qualunque esperienza sia meglio di nessuna esperienza» e dove «persino il dolore mi fa sentire viva».
Song to Song ci mostra sin dall’inizio un gruppo di persone perse nell’inautentico, in una sorta di eterno presente in cui l’unica cosa che conta è l’adesso («The future is now» dice Cook, il personaggio interpretato da Michael Fassbender). In una bellissima sequenza iniziale, girata durante uno dei concerti all’aperto della celebre scena musicale di Austin, seguiamo una serie di corpi che posano al rallentatore: saltano uno sopra l’altro in una sorta di dimensione vaga e dionisiaca in cui violenza, piacere e dolore si mischiano e si sovrappongono. È appunto il regno del corpo, un regno in cui conta unicamente la sensazione dell’immediato e dell’hic et nunc.
Tuttavia il tentativo di mettere in forma d’immagine lo stupore dell’uomo nei confronti del senso delle cose si ribalta spesso nel suo contrario: ovvero nella condanna di un’esistenza inautentica, persa nell’immediatezza di un materialismo deteriore, in cui l’essere umano non è più attraversato da alcuna domanda su se stesso e sul mondo. Ed è questa dimensione di “umanità inautentica” che Malick lascia emergere soprattutto nella rappresentazione di una sessualità paranoica e ripetitiva in cui i corpi femminili sono intercambiabili e “neutralizzati” in scene di orge e di godimento spersonalizzante e anonimo.
Una rappresentazione complessivamente tormentata e negativa, a cui il regista non nega, però, una flebile possibilità di riscatto: c’è sempre una luce che si staglia all’orizzonte, una via di fuga che indica una possibilità di salvezza, perfino nelle vicende di abbruttimento più estremo e feroce. «Segui la luce, va dove c’è la luce» si dice in una scena, quasi a voler mostrare quello che in ogni caso è sotto i nostri occhi per l’intera durata del film: lo sguardo incantato nei confronti del mondo è una precisa missione etica.