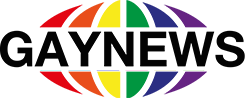La sposa è raggiante, col suo vestito di pizzo azzurro, le scarpe blu elettrico, la carnagione scura e i capelli raccolti in una treccia. Anche la moglie non è da meno, impeccabile nel suo tight e quell’elegante gilet che fa un bel contrasto col caschetto biondo. Sono emozionatissime, d’altra parte in tutti i matrimoni va così. E quando dall’altoparlante della chiama la voce scandisce “Le spose possono uscire!”, appena fuori dalla soglia parte una pioggia di riso che le raggiunge dai piani alti.
Questa è la storia di Camila e Adriana e del loro matrimonio speciale. Speciale, certo, perché solo da una manciata di tempo in Italia anche due donne o due uomini possono unirsi civilmente di fronte allo Stato. Speciale ancora di più, nel loro caso, perché la cornice dell’unione costituisce una prima volta, un inedito: il carcere femminile di Rebibbia a Roma.
Ho conosciuto Camila e Adriana in un assolato sabato di fine ottobre. La loro storia ha fatto scalpore e ha dato il via a un dibattito delicato, importantissimo, quello intorno all'”affettività in carcere“, la possibilità cioè per una coppia di stare insieme e scambiarsi baci e carezze nonostante le sbarre. Cosa evidentemente impossibile per un uomo e una donna, visto che i reparti dei penitenziari sono rigorosamente separati tra maschile e femminile. Fattispecie che per la prima volta in Italia si è realizzata invece là, nella cella numero 84 al secondo piano del reparto cellulare, ribaltando almeno in questo caso la gerarchia dei diritti tra eterosessuali e omosessuali del nostro Paese. I primi svantaggiati rispetto ai secondi, i secondi pronti ad aprire una strada nuova, che possa alla fine del percorso chissà… produrre un passo avanti per tutti.
La faccenda è delicatissima, e a spiegarmelo mentre raggiungiamo il reparto sono in tanti: la vicedirettrice del carcere, il cappellano di Rebibbia, il garante dei detenuti del Lazio e persino la damigella delle spose. E non è delicata solo in punta di diritto, bisogna andarci cauti proprio parlando d’amore.
Quando sei rinchiuso infatti, specie tra donne, è facile per la solitudine e per le tante mancanze che si soffrono scambiare un’amicizia per qualcos’altro, non fermarsi a una carezza e proseguire oltre.
«Speriamo che duri» è la frase che mi dicono tutti mentre raggiungiamo la cella delle spose: il cappellano, che si è ritrovato a fare da testimone il giorno del matrimonio; l’agente di polizia penitenziaria che «certo che ci sono andato alla cerimonia, una volta che succede una cosa bella qua dentro», la damigella che in questo strano condominio tutto di donne è la dirimpettaia della coppia.
Tutte queste attenzioni da parte dell’amministrazione, all’inizio, Camila e Adriana le avevano scambiate per una specie di “persecuzione”. Ora invece ci tengono a dire che sono grate a tutti, per la cura con cui hanno seguito la loro storia. E – naturalmente – per il lieto fine che è stato scritto: va bene, ha disposto alla fine la direzione del carcere, la vostra condotta è buona e anche il rapporto con le altre detenute, dunque potete condividere la stessa cella.
“La nostra casa“, la chiamano loro. Un letto a castello, un armadietto dove si intravede della frutta, un fornelletto elettrico, un cane in miniatura sopra a una specie di comodino, la TV accesa sul telegiornale, il bagno. Non c’è ordine in giro, c’è qualcosa di più: segni di una stanza vissuta, di una vita “normale”.
Una dimensione che Camila e Adriana si sono conquistate dopo due anni e più di qualche fatica. La principale quando Camila, la più grande delle due (ha 29 anni ma ne dimostra 25 come la sua compagna) ha ottenuto il permesso di andare a lavorare fuori durante il giorno. Un premio per le altre, una specie di tortura per lei che – arrivata dal Brasile solo quattro anni fa – dice «Adriana è tutta la mia famiglia».
La storia del dentro/fuori dura solo tre mesi: «Ci parlavamo dalle grate, lei al secondo piano io al piano terra», mi racconta Camila. Troppo, e così addio permesso premio e sono tornate insieme. Per Adriana quella è stata la prova definitiva del loro amore: all’inizio aveva paura che Camila si fosse sbagliata, che avesse solo scambiato un’amicizia per qualcosa d’altro.
Lei «omosessuale sin dalla nascita con altre storie alle spalle», la compagna al suo primo rapporto non eterosessuale. E così la scelta di sposarsi, e i confetti, e la festa nel chiostro del carcere, e quel primo lento insieme sulle note di Alessandra Amoroso prima di scatenarsi ballando con le altre detenute nello “spazio socialità”, e tutti commossi compresi i genitori di Adriana, due signori di origine polacca a Roma da una vita, che hanno dato una mano alle spose in tutto e per tutto: dai documenti per l’unione alle fedi, che le neospose indossano in coppia coi loro anelli di fidanzamento.
Sempre i genitori di Adriana aiuteranno tra qualche mese Camila, una volta uscita dal carcere. Vuole andare in Brasile per portare in Italia suo figlio Gabriel, che ha dieci anni e sa che mamma ha un’amica speciale che già gli va a genio, perché gli ha regalato un pallone firmato da Ronaldo che custodisce gelosamente nella sua cameretta.
E quando l’anno prossimo sarete fuori tutte e due, chiedo, come la immaginate la vostra vita? Avete già una casa dove andare tutti e tre? Prima di salutarci è Adriana a rispondermi, con la calma di chi dopo tanto penare non vuole precipitare le cose.
Andranno a stare per un po’ dai suoi, cercheranno un lavoro, un po’ di stabilità. Ma una cosa è certa, si piazzerà davanti alla playstation con Gabriel e partirà la sfida a due. Come succede in un sacco di case, come succede in qualunque famiglia.