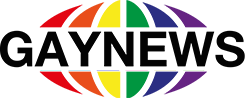L’uscita di Stefano Gabbana sulla questione omosessuale non è né nuova né originale. Si erano già pronunciati in merito persone più o meno ruotanti intorno alla collettività Lgbti.
È un dibattito che si svolge da tempo soprattutto per quanto riguarda i Pride (i Pride fanno bene o meno al movimento? Bisogna rivendicare o no la propria identità?). E ne approfitto per rimarcare un aspetto connesso alla questione. Aspetto che in realtà non ho mai accettato: l’eliminazione, cioè, del qualificativo gay dalla parola Pride in riferimento alle manifestazioni del 28 giugno. Cosa, in realtà, voluta e fatta dal movimento. Gabbana non dev’esserne informato. Altrimenti l’avrebbe potuto utilizzare come argomento. Naturalmente io continuo a parlare di Gay Pride forse perché sono un vecchio militante tradizionalista. Per utilizzare una frase di un film di Ozpetek, «Gay io? No, io sono frocio.
In questo annoso dibattito era intervenuto tempo fa anche Giorgio Armani – sia pur in modo diverso – dicendo: «Un uomo omosessuale è uomo al 100%. Non ha bisogno di vestirsi da omosessuale… Un uomo deve essere uomo».
Stupisce questa preoccupazione del maschile a tutti i costi. E stupisce per due ragioni.
In primo luogo uno è quello che è e non dovrebbe avere bisogno di sbandierarlo in giro per il mondo. Il doverlo fare rivelerebbe infatti l’esistenza di un problema. Se io, in riferimento all’identità di genere, sono e mi sento uomo (o donna) ma ho il bisogno di riaffermarlo su una maglietta, vuol dire che ho qualche problemino, e non da poco, al riguardo. Se invece non ho nessun problema, potrò conseguentemente decidere in piena libertà se dire di essere gay o meno.
E qui emerge l’altro punto dolente. Perché Gabbana mostra di confondere identità di genere con orientamento sessuale.
È vero che la distinzione al riguardo è recente. Distinzione dovuta alle culture della liberazione sessuale, al riconoscimento delle identità, ai Gay Studies, allo sviluppo degli studi scientifici in materia psicologica, alla militanza della collettività Lgbti. Ma l’errore è grossolano perché, come sappiamo tutti, è proprio su questo che si distingueva la vecchia guardia delle persone omosessuali in Italia.
Da questo punto di vista mi sovviene un ricordo dell’autunno dell’84. Era in corso una riunione con gli amici di Catania per dare vita al locale circolo dell’Arcigay (quello fu un periodo particolarmente importante per la nascita dei circoli, che poi avrebbero aderito, tra marzo e dicembre ’85, all’Arcigay Nazionale). In quell’incontro la metà dei presenti non si definiva omosessuale e sosteneva che l’omosessuale vero non si accompagna mai con un altro omosessuale. L’omosessuale vero, secondo gli intervenuti, sarebbe stato quello che si accompagna con un eterosessuale, aiutandolo a mettere su famiglia e, magari, ad allevare i di lui figli.
Sappiamo che Pasolini affermava più o meno la stessa cosa negli Scritti Corsari. Sappiamo anche che alcuni intellettuali d’orientamento omosessuale, appartenenti alla vecchia generazione, dicono tuttora che si stava meglio quando si stava peggio. Nel senso che nel periodo in cui la questione omosessuale non aveva un nome, non aveva una definizione, non era identificata, era impossibile non trovare un maschio che non fosse disponibile a fare sesso (magari da attivo) con un altro maschio. È noto che in passato (si parla di 40/50 anni fa) il ruolo dell’omosessuale di paese era quello di svezzare i ragazzi in modo che poi potessero finire sulla “retta via” sposandosi e facendo figli. È un’idea che non era solo delle persone omosessuali di vecchia generazione. Era un modo di pensare l’omosessualità condiviso anche dalla Chiesa cattolica che liquidava l’omosessualità quale fase transitoria dell’adolescenza.
In realtà, soprattutto nei piccoli centri, era fortissima la pressione sociale che spingeva a sposarsi e a farsi una famiglia. Al punto che persino molti giovani eterosessuali se ne lamentavano. Ricordo benissimo alcune mie conferenze nel corso delle quali, parlando di un tale argomento, intervenivano spesso 20/30enni etero dicendo: «I miei genitori e i miei amici mi hanno rotto le scatole perché non mi fidanzo». La stragrande maggioranza degli omosessuali finiva, d’altra parte, per sposarsi. Per poi continuare a frequentare i luoghi di battuage secondo una modalità ricorrente in passato e, in misura minore, ancora oggi.
Da un tale quanto complesso contesto deriva la su accennata preoccupazione. Preoccupazione che possiamo anche pensare come sincera. Non tutto, infatti, è sempre complotto, non tutto è sempre cattiveria, non tutto è sempre manipolazione.
Personaggi come Gabbana od Ozpetek, intervenuti su questa materia, mostrano di essere sostanzialmente feriti da due realtà.
Da una parte, che sia dato finalmente un nome alle cose. Non avendo un nome, infatti, il movimento e la stessa questione omosessuale banalmente non esistevano. Dall’altra, che si siano rese conseguentemente visibili tutte le omosessualità. Perché, giova ricordarlo, non esiste un solo modo d’essere omosessuali. Visibilità emergente soprattutto durante le manifestazioni dei Pride, che – come già detto sopra – continuano a far discutere sulla loro necessità.
Com’è noto, io milito tra coloro che dicono che i Pride fanno benissimo. In primo luogo, perché consentono il ritrovarsi in una manifestazione corale che ci fa vedere in grande quantità. Quest’anno ci sono stati 24 Pride (il massimo della storia in Italia) e quasi dappertutto dominati dalla presenza di giovanissimi, che non troviamo più nelle manifestazioni di partiti o sindacati. I Pride sono anche l’occasione per ribadire le piattaforme locali e le richieste che esse avanzano: da quelle ai servizi socio-sanitari a quelle assistenziali, dalle case d’accoglienza alla lotta contro povertà delle persone Lgbti.
Tornando alla questione del nome, confesso di essere molto affezionato alla parola gay come a quella in parte sinonimica di omosessuale. Sono affezionato perché è un mezzo fondamentale per rendere visibile l’omosessualità. Perché, piaccia o non piaccia, noi abbiamo una religione civile che è quella della visibilità. Veniamo da un mondo dove sono vissuti i nostri critici, compresi alcuni militanti. Un mondo dove ci si doveva nascondere. Dove ci si vergognava di essere omosessuali. Dove l’essere gay significava il perdere lavoro o gli affetti più cari. La doppia vita e la clandestinità sono state le cifre che hanno caratterizzato per troppo tempo la vita delle persone omosessuali. Frutto di quel compromesso concretatizzatosi in Italia in quella che Giovanni Dall’Orto ha chiamato “tolleranza repressiva”, creando quella sofferenza aggiuntiva che Vittorio Lingiardi ha definito come “Minority Stress”.
Ci si deve infatti sempre chiedere quali sono i costi sociali del negare se stessi o se stesse. Quale livello di infelicità domini ancora in milioni di donne e uomini omosessuali che continuano a non “dirlo” a se stessi prima ancora che alla famiglia e agli amici.
È sufficiente per tutte queste persone dire “Io sono uomo” o “Io sono donna” per determinare un processo di liberazione e di vivibilità? Io direi di no.
Per non parlare, e qui torniamo alla preoccupazione di molti nel sottolineare la propria mascolinità, del rischio di un pericoloso ritorno del maschilismo anche in campo gay. Sappiamo bene che questa cultura incistata fin dalla nascita nei nostri cervelli e coltivata dalla scuola, dallo sport, dalla famiglia, ha prodotto i danni più rilevanti, i conflitti più dolorosi. Ha prodotto l’esercizio del potere escludente, il bullismo, la violenza verso la diversità (proprio quella che Trump vuole cancellare dai report dell’Acdc, l’agenzia sanitaria di Stato Usa).
Stiano attenti, quindi, alcuni amici: mettendosi controvento e obiettivamente dalla parte di tutti i nostri avversari storici, essi scherzano col fuoco. Si può essere – e, in non pochi casi, si deve essere – critici verso il movimento Lgbti. Ma senza toccare mai il fondamento della nostra esistenza e della nostra lotta.