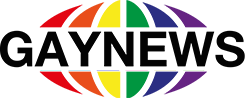«Anche se gli Stati membri sono liberi di autorizzare o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, essi non possono ostacolare la libertà di soggiorno di un cittadino dell’Unione europea rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di un Paese non Ue, un diritto di soggiorno derivato sul loro territorio».
Questo il punto nodale della sentenza emessa, il 5 giugno, a Lussemburgo dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il caso su cui la Corte ha emesso il suo verdetto è quello di un cittadino romeno, Relu Adrian Coman, che si era visto rifiutare dalle autorità del suo Paese il diritto di soggiorno superiore a tre mesi per il proprio compagno, il cittadino statunitense Robert Clabourn Hamilton, con cui si era sposato a Bruxelles nel 2010.
Per una valutazione della sentenza Gaynews ha chiesto il parere dell’avvocato trentino Alexander Schuster.
La sentenza Coman del 5 giugno è una sentenza molto attesa ed è stata adottata dalla Grande Sezione, cioè dalla composizione massima della Corte per questo tipo di procedure. È una causa che come ECSOL abbiamo seguito negli ultimi anni, intervenendo anche nella procedura in Romania.
Complici i soliti titoli enfatizzati dei quotidiani, mi pare però che la sua portata sia stata fraintesa. Non è una sentenza propriamente sul riconoscimento fra Stati membri dell’Unione europea del matrimonio fra due persone dello stesso genere. È più correttamente una sentenza sul diritto di colui che in uno Stato membro risulta validamente come coniuge di godere del diritto di soggiornare in quanto stretto familiare di un cittadino dell’Unione in un altro Stato membro.
In altri termini, la Corte di giustizia non entra nel merito di un obbligo generalizzato di riconoscimento dei matrimoni e si limita ad affermare che il coniuge deve essere trattato quale coniuge ai fini del diritto di entrare e soggiornare in qualsiasi Stato membro dell’Unione. Questa era la questione posta dalla Corte costituzionale rumena e non è prassi della Corte di giustizia fare considerazioni al di là di quanto necessario per rispondere al quesito posto.
In tal senso è l’esito che attendevo. Nulla di più, perché non è nello stile della Corte. Ma anche nulla di meno, perché affermare che gli Stati potevano negare il diritto di vivere insieme alle coppie omosessuali sarebbe stato un grave segnale e soprattutto un passo incompatibile con sentenze della Cedu come Pajic c. Croazia e, soprattutto, Taddeucci e McCall c. Italia.
Ci sono nella sentenza, però, alcuni segnali utili per capire l’orientamento della Corte rispetto al grande tema del matrimonio.
La Grande Sezione afferma che gli Stati membri sono liberi di optare o non per il matrimonio egualitario. Quindi, i 28 Stati membri non incorrono agli occhi dell’Unione, almeno ad oggi, in nessuna violazione se non consentono l’accesso al matrimonio. È, infatti, ribadita la loro competenza in materia di stato civile e, quindi, di matrimonio.
E tuttavia – e qui c’è margine per futuri sviluppi – i cittadini dell’Unione godono del «diritto di condurre una normale vita familiare» quando circolano da uno Stato all’altro. La Corte cita così il filone giurisprudenziale da Vallianatos c. Grecia a Orlandi c. Italia, che incorpora l’importante principio enunciato in Oliari c. Italia.
Per quanto fosse scontato che la tutela della vita familiare nell’Unione dovesse essere almeno pari di quella garantita dalla Convenzione europea per i diritti umani, l’espresso riconoscimento che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione tutela le coppie dello stesso genere quale famiglia è un recepimento espresso di assoluto rilievo. I cui frutti speriamo di cogliere in giurisprudenza futura.
In tal senso il paragrafo con la giurisprudenza di Strasburgo sulla vita familiare appare più che la conclusione del ragionamento dei giudici di Lussemburgo, l’annuncio di un percorso appena iniziato.