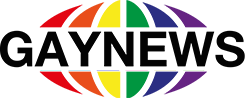Durante la rassegna sportiva dei ventottesimi Giochi del Mediterraneo, nati nel 1948 come una sorta di olimpiade dei Paesi che si affacciano sull’omonimo mare, le atlete azzurre Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e la campionessa europea Libania Grenot hanno trionfato nella specialità atletica della staffetta grazie ad un tempo di 3:28.08.
Si è subito creato il classico carro dei vincitori, su cui sono saltati in molti, compreso chi continua a parlare a mezzo stampa e sui social del quartetto “di colore”.
Quasi a dire: Ecco, se vengono e corrono per noi allora va bene. Eppure sembra alquanto ipocrita parlare di integrazione nello sport senza considerare lo stesso sport come parte integrante della società. Le ragazze hanno vinto non solo perché “lo sport unisce” (uno slogan che può voler dire qualsiasi cosa), ma perchè ci sono segmenti e contesti sociali molto più avanti del dibattito politico, in grado di unire anche grazie allo sport.
Per parlare di sport bisogna immaginare un organismo complesso, di cui le vetrine di Olimpiadi e Mondiali sono solo le vette più alte di un movimento di proporzioni vastissime. Bisogna pensare ai campi e alle palestre di periferia, agli enti di promozioni, ai comitati federali locali, che riguardano la capacità delle scuole di lavorare in termini sostegno allo sport e all’integrazione. L’ondata di razzismo di oggi, i morti in mare, le parole d’odio del vocabolario politico, saranno sicuramente una ferita profonda nella mente di tanti futuri e atleti e atlete migranti di seconda generazione. Perché possibilmente quei futuri atleti e atlete stanno tra gli 800.000 bambini e bambine ai quali è stato negato lo ius soli, ad esempio.
Per fortuna c’è chi dimostra una volta per tutte che l’italianità non è fatta dal colore della pelle, ma da tutto quello che rende unico un Paese: i valori, la cultura, i cibi, i territori, le organizzazioni, il modo di creare movimento, compreso lo sport.
Multiculturalità non significa avere “qualcun altro” che va bene quando c’è da correre, ma vuol dire inclusione di tradizioni diverse come valore fondate della propria cultura. E anche qui lo sport può insegnarci tantissimo. Qualcuno forse penserà che i nomi di queste ragazze non sono abbastanza “italiani”. Basta vedere i cognomi di alcuni giocatori della nazionale argentina ai mondiali: Armani, Tagliafico, Di Maria, Mascherano, Ansaldi, Biglia, Fazio. I loro bisnonni erano tutti migranti che venivano dall’Italia.
Infine, la vittoria delle nostre ragazze riporta alla ribalta la questione del professionismo femminile. Come Rachele Bruni e Federica Pellegrino, il quartetto che celebriamo oggi è ufficialmente un gruppo di atlete dilettanti. L’Italia è ancora l’unico Paese Europeo a non riconoscere come professioniste le atlete. Questa è una delle sfide da vincere nell’immediato ed è ormai una sfida globale considerando anche lo stretto legame tra il pregiudizio sessista e quello omofobico, che si riflette anche nella Carta Olimpica internazionale ormai dal 2014.

È innegabile, ad esempio, che molti passi avanti delle donne nei Paesi di cultura araba abbiano beneficiato di immagini di impatto mondiale come quelle delle giocatrici di beach volley egiziane e tedesche a confronto scattate a Rio 2016, le prime completamente coperte con tanto di velo, le seconde in bikini.
Non solo quell’immagine è stata motore di visibilità e cambiamento, ma, a sua volta, il coraggio delle atlete egiziane arrivate fin lì era testimone di un cambiamento già in essere, seppur lento e faticoso, in tema di diritti delle donne nel mondo arabo.
Lo sport può cambiare la società insomma, a patto che a partire dai media e dalla politica non sia visto come una mera vetrina, ma come uno strumento fondamentale per leggere e intervenire sui processi culturali.