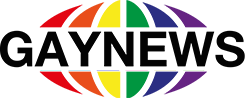La domanda è sempre la stessa: quanto si è disposti a rinunciare di sé per compiacere il proprio pubblico? Quanto di quello che ci giunge di un artista è un prodotto costruito a tavolino e quanto semplicemente un messaggio spontaneo di ciò che si è vissuto, di ciò che si prova? E quando un artista può definirsi tale e non una mera costruzione artificiale appagante le mode del momento?
Soprattutto la prima domanda ha tormentato Rufus Wainwright, almeno nella prima parte della sua carriera, quando sembrava avere tutti i requisiti per diventare una grande pop star. Una certa avvenenza, una voce incredibilmente flessibile e potente, un talento da songwriter non comune. E perché no, quel suo dichiararsi sfrontatamente gay – cosa che 20 anni fa non era ancora così sdoganata -, nemmeno nello showbiz delle grandi multinazionali discografiche.
La fama arrivò, per la verità, non nella misura attesa: Rufus non è mai diventato Robbie Williams, pur avendo un talento infinitamente superiore. E, con la fama, i problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, le pressioni di chi voleva cucirgli addosso un personaggio in cui Mr Wainwright non si riconosceva, gli scandali, per la verità bonari e per niente costruiti ad arte, come quando ospite a Sanremo frange di cattolici ultraconservatori volevano impedirgli di cantare il suo Gay Messiah.
Beh, alla fine, durante la splendida performance del 28 Luglio presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Rufus Wainwright, tra una canzone e l’altra, ha raccontato come a un certo punto avesse capito che, nonostante il forte desiderio del successo, non sarebbe stato capace di gestirlo. Ma anche come oggi, da marito di Jörn Weisbrodt e papà di Viva Katherine, a interessargli sia solo scrivere belle melodie, sentirsi libero di essere se stesso e dare emozioni al proprio pubblico.
Due ore abbondanti di concerto in completa solitudine, durante le quali, accompagnato solamente da un pianoforte a coda e una chitarra, ha preso per mano, in un crescendo emotivo, un pubblico attentissimo, col quale ha ripercorso la sua carriera a ritroso e per il quale ha eseguito brani dal prossimo disco in uscita ad aprile 2020. Senza contare il grato omaggio ad altri grandi artisti con delle splendide cover.
Una su tutte Hallelujah, che nei suoi concerti non manca praticamente mai. Quando una volta gli è stato chiesto se non lo stancasse cantare quel brano a ogni evento, ha risposto che l’eseguirlo crea sempre una strana connessione col pubblico. Una connessione che spera di mantenere ancora a lungo.
Non un briciolo di noia, dunque, nel seguirlo nel suo mondo. Quasi fossimo stati seduti tutti idealmente intorno al suo piano, sorseggiando qualcosa da bere e aspettando ognuno soltanto il turno della propria canzone preferita. La mia è arrivata a metà concerto con Dinner at eight, in cui racconta il rapporto di amore burrascoso col padre, anch’egli musicista di grande talento.
È stato verso la fine del concerto che Rufus Wainwright ha risposto alla famosa domanda. Tirato via il microfono e abbandonato il fido amico pianoforte, ha cantato, solo, “nudo”, a cappella, affermando, forte di una maturità sofferta ma acquisita, che oggi non è disposto a rinunciare a nulla di ciò che è, di ciò in cui crede per compiacere nessuno.
E, se questo significa anche schierarsi apertamente contro le politiche di Trump e sostenere la battaglia per i diritti delle persone Lgbti, ancor più ben venga. Già, perché, signori e signore, questo è un artista. Un grande artista.