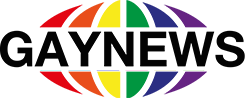A volte un’influenza, anche in tempi di deliro da Coronavirus, ti dà l’opportunità di valutare e ricordare cose che altrimenti resterebbero in un’anonima stanza della memoria. Uno speciale dedicato a Joni Mitchell, su quel raro faro di cultura nel panorama televisivo odierno che è Rai5, me ne offre l’occasione.
A volte un’influenza, anche in tempi di deliro da Coronavirus, ti dà l’opportunità di valutare e ricordare cose che altrimenti resterebbero in un’anonima stanza della memoria. Uno speciale dedicato a Joni Mitchell, su quel raro faro di cultura nel panorama televisivo odierno che è Rai5, me ne offre l’occasione.
Due le artiste che sono state le responsabili della mia forte dipendenza musicale, credo ormai irreversibile. Kate Bush e Joni Mitchell appunto. Quando iniziai ad ascoltare la loro musica, non ero cosciente di chi fossi ancora veramente. Una sorta di larva avvolta in un bozzolo indeciso sul cosa sarei dovuto diventare. Per qualche misterioso motivo, in molte delle loro canzoni sentivo tracciato un messaggio, probabilmente cifrato.
Il documentario di Stephanie Bennett Joni Mitchell – A woman of Heart and Mind, trasmesso in prima visione su Rai5 il 14 gennaio e, nuovamente, il 27 febbraio, è una biografia confessionale della cantautrice-poeta-pittrice canadese.
Nel corso della lunga intervista, risalente al 2003 e arricchita da testimonianze di David Crosby, Graham Nash, Neil Young, Judy Collins e Bob Dylan, Mitchell asseriva che la sua musica non è mai stata asservita all’industria discografica ma solamente alla sua ispirazione. Perché voleva che potesse essere a sua volta fonte di ispirazione per chi volesse ascoltarla, non sentirla, ascoltarla. Era necessario per questo essere fino a fondo se stessi, mettersi a nudo fino a rendersi vulnerabili.
Beh, oggi alla soglia dei 50 anni posso dire che alcune canzoni sono state un faro, un’ancora, un appiglio per non sprofondare negli anni e nei momenti di maggiore fragilità. Anche se allora non lo sapevo. Non so bene cosa io sia diventato ma so bene cosa non sono diventato. Cioè, tutto ciò che non volevo diventare. Ed è già un successo.
Musicalmente si potrebbero scrivere trattati sull’opera di entrambe: basti dire che in molte università del Canada e degli Stati Uniti i testi di Joni Mitchell vengono studiati al pari delle poesie dei grandi della letteratura del ‘900.
Torno invece a un livello più emozionale e inconscio. Anni dopo mi capitò di imbattermi in un articolo che raccontava come un’appena 19enne Kate Bush cantasse al piano, in una trasmissione pomeridiana per ragazzi introdotta da un ignaro presentatore, Kashka from Baghdad: Kashka da Bagdad vive nel peccato / con un altro uomo dicono / Ma nessuno sa chi è….. Al calar della notte sono visti / ridere, amarsi / loro conoscono il modo / per essere felici.
Era il 1978. Facile immaginare l’imbarazzo del presentatore alla fine del brano suonato dal vivo da quella talentuosa ragazzina nel pieno del suo candore. Era invece il 1974 quando nel suo album Court and Spark, successore di quel capolavoro assoluto che fu Blue, dal quale volutamente si discosta abbracciando sonorità meno intimistiche, Joni Mitchell include Free man in Paris.
Erano gli anni di Laurel Canyon a Los Angeles, luogo dove stavano nascendo gli ultimi sogni per una società occidentale più equa e giusta, fucina di talenti: ci si scambiavan esperienze, si creava musica per generazioni di giovani con ancora ideali e speranze per un mondo migliore, che si sarebbero infrante solamente qualche anno più tardi.
Ma torniamo alla canzone: chi era “l’uomo libero a Parigi”? Sicuramente David Geffen, amico e produttore discografico, col quale Mitchel avrebbe poi condiviso un viaggio a Parigi, lontana da tutti gli impegni di lavoro.
Geffen avrebbe successivamente dichiarato che, ascoltando per la prima volta il pezzo, si sentì imbarazzato dal fatto di come una canzone di tre minuti e poco più, scritta da qualcun altra, avesse potuto sintetizzare il suo intero mondo interiore. Basta? No, ovviamente.
L’uomo libero a Parigi era anche la stessa Mitchell, personaggio inviso all’industria discografica che, ogni qual volta cercava di classificarla e confinarla nello stereotipo persona-genere musicale, subiva un repentino cambio di prospettive. Prospettive, che scompigliavano i piani di marketing e previsioni di vendite che, evidentemente, erano l’ultima cosa a interessare l’artista canadese. Quando Charlie Mingus, mostro sacro del jazz, prossimo alla morte, le chiese di fare un disco insieme, in cui i testi della Mitchell raccontassero i di lui rimpianti, desideri, ricordi, tutti le sconsigliarono di farlo, sapendo che sarebbe stato un suicidio commercialmente parlando. Joni Mitchell ovviamente lo fece. Basta? Non ancora.
L’uomo libero a Parigi doveva essere ogni persona che avesse ascoltato la canzone e che avesse la forza e il coraggio di essere se stessa senza il timore del giudizio altrui, intellettualmente, sessualmente, moralmente parlando.
David Geffen si diceva all’epoca bisessuale: nota la sua storia con Cher. Solo anni dopo avrebbe fatto coming out come gay, dedicandosi alla causa dei diritti Lgbt+ e battendosi contro la Proposition 8, che, soggetta a referendum il 4 novembre 2008, abrogava il matrimonio tra persone dello stesso sesso, introdotto nello Stato della California il 15 maggio precedente.
Nel 1974 Geffen e Mitchell erano entrambi giovani e nulla del futuro era prevedibile. Joni disegnava con Free man in Paris un ideale di libertà incondizionata, al quale ognuno di noi dovrebbe ambire a prescindere da religione, sesso, etnia. Un respiro d’aria fresca, una dichiarazione di interesse e, al contempo, non interesse di quali potessero essere le preferenze sessuali di David Geffen, di ognuno di noi: Non puoi piacere a tutti / Ci sarà sempre qualcuno a buttarti giù /…. Ma sono un uomo libero a Parigi / Senza restrizioni e vivo.
Ora, alla soglia dei miei 50 anni, so quel che non sapevo allora. Cioè, perché quel ragazzino che ero amava Kate Bush e Joni Mitchell. Il messaggio era: Sei un uomo libero a Parigi, senza restrizioni e vivo. Si lo sono e orgoglioso di esserlo.