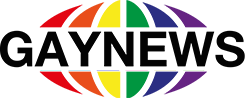Devo ammetterlo. Quando una decina d’anni fa irruppe sulla scena musicale Lana Del Rey con la sua avvenenza plastificata, avevo avuto l’impressione che si trattava di un progetto discografico da liquidare come artefatto. Un progetto con poco da dire nonostante due o tre colpi ben assestati nell’album d’esordio Born to die. Esibizioni dal vivo a dir poco imbarazzanti parevano avallare quello che pensavo. E, cioè, che forse ne avremmo sentito ancora parlare, visto il successo ottenuto, come un mero prodotto da classifica.
Quanto può essere piacevole essersi sbagliati e doversi ricredere riconoscendo i propri errori? Nel corso degli anni Lana ha progressivamente guardato altrove, abbandonando quello che poteva ed era effettivamente un comodo sentiero per vivere sugli allori. Si è spogliata della comoda (e scomoda allo stesso tempo) veste di sex-symbol, di ennesima icona gay tutta ammiccamenti e allusioni per andare oltre, molto oltre. Ha progressivamente analizzato il contesto sociale americano. Lo stesso che le ha dato successo e notorietà e che l’aveva gettata, in età adolescenziale, nell’alcolismo, per portarla a produrre dischi a mano a mano più complessi. Fino ad arrivare a Norman Fucking Rockwell!, che ne è la summa e la sintesi al contempo.
Norman Rockwell fu probabilmente l’illustratore più celebre d’America. Le sue copertine hanno tracciato i connotati della perfetta società a stelle e strisce, della perfetta famiglia nordamericana. Insomma, l’incarnazione del famigerato sogno. Lo stesso che Lana e i suoi collaboratori destrutturano fino a celebrarne il fallimento attraverso dischi apparentemente pop e innocui. Non è una rivoluzione rumorosa quella di Lana. È solamente la cronaca di una progressiva e lenta disillusione. L’ex ragazzona sexy guarda sempre più alla California anni ‘70 di Laurel Canyon, di cui i suoi fan della prima ora, quei millennials tutti social e musica usa e getta, ignorano l’esistenza e il significato culturale. Quasi commovente vedere il video semi-amatoriale, in cui insieme a Zella Day e Weyes Blood (un’altra il cui ultimo disco non dovrebbe mancare nei vostri scaffali) prova For free di Joni Mitchell, che già più di quarant’anni fa puntava i riflettori sul rapporto spesso difficile tra arte e industria discografica.
Certo di Mitchell non ha il talento e non ha nemmeno la presenza scenica di una Stevie Nicks, alla quale mi parve poterla paragonare ai suoi esordi, un po’ impietosamente. Ma semplicemente Lana Del Rey oggi riesce a essere Lana Del Rey. Si esibisce dal vivo ancora un po’ come una tredicenne alla recita scolastica di fine anno, ammicca alle nuove generazioni ben sapendo che la sua nuova musica guarda altrove, bel lontano verso il passato. Ha saputo circondarsi dei collaboratori giusti. Norman Fucking Rockwell! si può ben dire che sia un progetto concepito a quattro mani col produttore e polistrumentista Jack Antonoff, noto anche per essere stato un seguitissimo blogger su Huffington Post dove trattava tematiche relative ai diritti della comunità Lgbti.
Le canzoni di NFR ti si avvinghiano addosso con quella dolce malinconia che solo le strade assolate di Los Angeles, viste da una vecchia decappottabile, possono conferire a un presente apparentemente tanto roseo quanto effimero, sul punto di cadere a pezzi come un set cinematografico. Oggi più che mai. Questa è l’America che ci racconta Lana Del Rey, ben sapendo di farne parte, snocciolando una canzone dopo l’altra, il campionario completo delle crepe della moderna società americana che Norman Rockwell dipinse così bene. Un disco senza tempo, sicuramente il migliore della sua carriera, pieno di nostalgia, rimpianto e, appunto, assolata malinconia. Lana sa di maneggiarla molto bene quest’ultima.
Non a caso nel concerto tributo, che Adam Cohen ha dedicato al padre Leonard nel 2017, è stata chiamata a eseguire Chelsea Hotel, scritta dal grande poeta e cantautore canadese sull’amore non corrisposto nei confronti di Janis Joplin. Lana l’ha cantata a modo suo, quasi fosse capitata lì per caso scelta dal pubblico. Ci sono voluti anni per capire che invece non è il caso ad aver fatto di Del Rey la nuova portavoce di una disillusione che viene da lontano, molto lontano. Meglio tardi che mai.