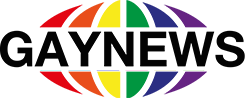La Cassazione ha confermato la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, benché il rapporto coniugale fosse durato più di dieci anni e arricchito da tre figli.
La Cassazione ha confermato la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, benché il rapporto coniugale fosse durato più di dieci anni e arricchito da tre figli.
È quanto stabilito lunedì 20 aprile, con ordinanza nr. 7923/2020, dalla Prima Sezione civile della Suprema Corte (presidente Maria Cristina Gianicola, relatrice Clotilde Parise), che ha convalidato il riconoscimento dell’efficacia nell’ordinamento italiano di una sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese, con la quale era stata dichiarata, nel 2012, la nullità di un matrimonio celebrato nel 1990 da una coppia salentina «a causa dell’omosessualità della moglie». Sentenza che era stata recepita dalla Corte d’Appello di Lecce nel 2017.
Invano la Procura generale si è opposta parlando di decisione «discriminatoria della libertà sessuale e affettiva» della donna «biasimata a causa del suo orientamento sessuale e per questo considerata affetta da disturbo grave della personalità».
Secondo la procuratrice generale Francesca Cerioni, in questo modo, sarebbe stato violato il «limite dell’ordine pubblico interno e internazionale», con riferimento al «diritto fondamentale di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva sancito dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché con riferimento al principio di non discriminazione».
Le giudici hanno respinto il ricorso della Procura generale, condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, come affermato anche dalle Sezioni unite, non è possibile in situazioni simili, – riferibili al «limite di ordine pubblico» e alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio – la «rilevabilità d’ufficio», mancando un ricorso, come in questo caso, dei coniugi interessati. In ogni caso, la Corte ha ritenuto non fondata la doglianza relativa alla «decisiva rilevanza dell’omosessualità» della signora. «La condizione soggettiva della moglie – così nell’ordinanza – non è stata affatto l’unica ragione fondante la decisione del giudice ecclesiastico».
Per la Prima Sezione il «vizio di nullità del matrimonio è dipeso dalle condotte di entrambi i coniugi, in base a quanto accertato nella sentenza impugnata», per cui «non rivestono rilevanza alcuna, nella specie, il principio di non discriminazione o il diritto di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva nel senso prospettato nel ricorso».
Ma, come confermato al nostro giornale da un giudice rotale, è prassi ricorrente nelle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale considerare l’omosessualità di uno dei coniugi quale causa dirimente in quanto disturbo grave della personalità.
A fare il punto della situazione a Gaynews l’avvocato trentino Alexander Schuster, che ha osservato: «C’è da ribadire che le parti rilanciate dai media, fortemente intrise di pregiudizio e di una visione dell’omosessualità come malattia, sono contenute nella sentenza del giudice ecclesiastico e non sono fatte proprie dalla Cassazione. Questa rileva che la nullità pronunciata dai giudici dell’ordinamento canonico si poggia su diversi motivi ulteriori rispetto all’omosessualità ed è per questo che non può essere contraria all’ordine pubblico (ad esempio, negazione dell’indissolubilità del matrimonio del marito o vizi dei bona matrimonii della moglie).
Va poi osservato che la sostanza dell’esito è riconducibile al fatto che la moglie non ha chiesto di “tenere in piedi” il matrimonio, cosa che avrebbe potuto fare con certezza dell’esito. Ed è una domanda che solo uno dei coniugi può rivolgere al giudice, come ebbero a chiarire le Sezioni unite nel 2014. Semplificando il dato tecnico, a chiedere di continuare ad essere marito e moglie deve essere almeno uno di loro. Non può imporlo d’ufficio il giudice. Insomma, chi non vuole subordinare la propria vita di coppia alle peculiarità dei tribunali ecclesiastici e alle regole e placet di Santa Romana Chiesa, è meglio che si sposi solo in Comune o comunque prima in Comune».