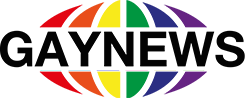Il Covid-19 è, come noto, un problema di dimensioni mondiali. Dall’Africa continuano ad arrivare immagini di richieste di solidarietà per la grande mortalità infantile ma poco su ciò che accade alla popolazione in termini di contagio. In Italia è quasi nulla l’informazione sulle popolazioni presenti nelle aree a più forte esclusione sociale. Abbiamo perciò cercato di fare il punto di situazione con Carmen Bertolazzi, presidente dell’Istituto internazionale di Scienze mediche antropologiche e sociali (Iismas), operante da anni nel Corno d’Africa.
Il Covid-19 è, come noto, un problema di dimensioni mondiali. Dall’Africa continuano ad arrivare immagini di richieste di solidarietà per la grande mortalità infantile ma poco su ciò che accade alla popolazione in termini di contagio. In Italia è quasi nulla l’informazione sulle popolazioni presenti nelle aree a più forte esclusione sociale. Abbiamo perciò cercato di fare il punto di situazione con Carmen Bertolazzi, presidente dell’Istituto internazionale di Scienze mediche antropologiche e sociali (Iismas), operante da anni nel Corno d’Africa.
Nel nostro Paese e in Europa si è impegnati nella lotta contro il Covid-19. I media informano su quanto sta accadendo nel nostro continente, in Cina e negli Usa. Ma poco o nulla di ciò che accade in Africa. Che idea ti sei fatta al riguardo?
Dell’Africa non si parla mai. Comunque non interessa, se non per le vacanze e per pubblicare foto di bambini scheletrici allo scopo di raccogliere fondi, che servono poi, ahimè, troppo spesso a mantenere strutture organizzative mastodontiche. E questo è. Si parla troppo poco di Paesi che, depredati nel periodo coloniale e in alcune parti ancora oggi dall’Europa, cercano di crescere soprattutto nel campo dell’educazione, della sanità e del turismo alla ricerca di affidabili partner finanziari per poter sviluppare la propria economia. Avremmo da imparare molto dall’Africa. Ma per ora prevale, quando si può, lo sfruttamento. Questa è la grande ingiustizia sociale: loro muoiono di malaria, noi l’abbiamo debellata da decenni, noi possiamo curare i tumori, loro no, nemmeno la diarrea, noi combattiamo l’obesità, loro devono affrontare denutrizione e malnutrizione, e via dicendo. L’Africa non fa notizia, soprattutto in Italia, e soprattutto quando si tratta di raccontarla nelle sue sfide e nei progressi che quotidianamente affronta con coraggio.
Per il tuo impegno professionale sei un’esperta conoscitrice del Corno d’Africa. Hai notizie su ciò che sta accadendo?
La situazione in Africa si presenta a macchia di leopardo. Pessima situazione in Sudafrica, che peraltro ha chiuso subito le frontiere rispedendo a casa moltissimi lavoratori mozambicani, facendo mancare così un sostegno vitale a molte famiglie di un paese di per sé povero. Molti casi, anche, nel minuscolo stato di Gibuti, che è un vero e proprio porto di mare. E anche in Egitto i numeri sono considerevoli così come nei paesi magrebini. Comunque dati relativamente bassi, non comparabili a quelli europei, americani e cinesi. Perché? Non esiste una risposta scientifica: forse è un ritardo stagionale, forse perché è una popolazione molto giovane, forse perché paradossalmente più forti dal punto di vista immunologico. Nel resto dei Paesi subsahariani non si registrano al momento grandi numeri. Nel corno d’Africa i casi sono molto limitati, avendo Etiopia, Somalia ed Eritrea chiuso subito le frontiere, imposto la chiusura in casa e in alcuni paesi, quali l’Etiopia, uno stato di emergenza per sei mesi. Ovviamente l’ultima misura può essere politicamente dal punto di vista delle garanzie costituzionali molto rischiosa, come denunciato dagli osservatori internazionali.
In caso di una pandemia diffusa e importante nei numeri cosa potrebbe succedere? Quali i rischi?
I Paesi africani non sono attrezzati ad affrontare una pandemia simile dal punto vista sanitario, per carenza, se non assenza, di posti letto, apparecchiature, terapie, laboratori e via dicendo. Peraltro si è bloccato il flusso della valuta pregiata, ossia i dollari e gli euro, proveniente dalle rimesse dei migranti, dagli investimenti stranieri e dal turismo, essenziale per gli acquisti dall’estero tra cui anche il cibo. In Etiopia, paese in cui normalmente passo metà del mio tempo, si teme il contagio, consapevoli di non avere gli strumenti necessari. L’ordine è stato di tutti a casa in attesa del loro periodo invernale, che inizia a maggio con le piccole piogge per poi passare alle grandi piogge che terminano a settembre. Sono come in una lunga attesa, pregando molto (sono ortodossi copti) per scongiurare il contagio, mentre hanno introdotto alcune importanti misure di prevenzione.
In un continente che vive di agricoltura come fanno i contadini a non andare nei campi?
Si rischia una forte carestia, già in agguato in alcune regioni causa invasione di cavallette. E tutte le persone, la maggior parte di intere popolazioni, che vivono di economia informale per mantenere la famiglia, ora che faranno? Non si morirà di Covid-19 ma di fame: questo è il rischio. Sono popoli resilienti, molto, molto di più delle nazioni, ma questo non impedirà di creare una nuova discriminazione. Se la pandemia arrivasse in proporzione simile alle nostri, morirebbero più persone che in Europa, America e Cina messe insieme.
Da anni ti occupi delle persone vittime di tratta. In questo momento, a tuo parere, cosa sta succedendo? C’è una riorganizzazione in atto di coloro che la attuano o sono tutti fermi?
Per il contrasto alle vittime di tratta e di sfruttamento è importante riuscire a contattarle, per strada, nelle case o via internet. Ormai è impossibile: sono doppiamente ostaggio dei padroni dello sfruttamento e non potendo lavorare, non possono nemmeno ripagare il debito. Anzi, il debito aumenterà a dismisura durante il periodo di chiusura. Per loro ora non è pensabile avere alcun rapporto con chi potrebbe aiutarle a lasciare il circuito dello sfruttamento, dalle unità di strada ai clienti. Il problema esiste ovviamente anche per le sex worker, ossia chi si prostituisce autonomamente e liberamente. Chiuse in casa, non sanno come mantenersi, pagare l’affitto, le bollette e per loro non esistono i paracaduti sociali, soprattutto se straniere e non in regola con il permesso di soggiorno. Molte sono state sfrattate, vivono per strada, in situazione promiscua e non possono oggettivamente rispettare le regole di prevenzione per il Covid-19 mettendo a rischio la propria salute e vita.
Che cosa fanno e possono fare le associazioni?
Per le sex worker si è organizzata una rete di solidarietà che parte dal Comitato per i diritti delle prostitute di Pordenone, da Ombre rosse e dalle associazioni trans come il Mit, a cui hanno aderito moltissimi enti. A questa sottoscrizione nazionale si sono aggiunte azioni territoriali, ossia ciascun ente fa quello che può, raccogliendo fondi e generi alimentari per distribuirli a chi non ha mezzi di sostentamento. Come reti nazionali degli enti anti-tratta abbiamo chiesto al Dipartimento delle Pari opportunità di permettere una flessibilità nell’utilizzo dei fondi già a nostra disposizione, per riuscire a rispondere a bisogni primari in questo periodo di emergenza. Cerchiamo di supportare tutte le persone con cui siamo entrate in contatto e portare loro degli aiuti, sia che facciano parte dei nostri progetti antitratta sia che siano rifugiate o sex worker. La solidarietà non tollera giudizi e discriminazioni.