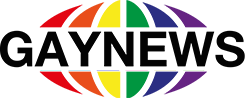Il tema delle discriminazioni e violenze per sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, la cui prevenzione e il cui contrasto sono l’oggetto del testo del disegno di legge in esame alla Camera dei deputati, continua a suscitare dibattito in attesa che riprendano i lavori d’Aula nel mese di settembre. Dibattito che continua soprattutto a incentrarsi sulla libertà d’opinione e, sia pur minoritariamente, su genere e identità di genere.
Il tema delle discriminazioni e violenze per sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, la cui prevenzione e il cui contrasto sono l’oggetto del testo del disegno di legge in esame alla Camera dei deputati, continua a suscitare dibattito in attesa che riprendano i lavori d’Aula nel mese di settembre. Dibattito che continua soprattutto a incentrarsi sulla libertà d’opinione e, sia pur minoritariamente, su genere e identità di genere.
Abbiamo cercato di sciogliere il proverbiale nodo gordiano, o almeno maggiormente approfondire la questione, con Elettra Stradella, professoressa associata di Diritto pubblico comparato e presidente del Comitato unico di Garanzia dell’Università di Pisa. L’accademica di origine genovese è autrice di più di 100 pubblicazioni scientifiche e dirige per la Pisa University Press la collana “Genere, soggettività, diritti”, all’interno della quale ha curato nel 2019 il volume collettaneo Le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.
Professoressa Stradella, il testo unificato del ddl sul contrasto e la prevenzione delle discriminazioni e violenze per sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere ha accolto il cosiddetto emendamento “salva idee”. Secondo lei era necessario ribadire quanto disposto dall’art. 21 della Costituzione?
L’emendamento cosiddetto “salva idee”, approvato nelle scorse settimane dai partiti della maggioranza insieme a Forza Italia, chiarisce che “Ai sensi della presente legge, sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte”. La formulazione, forse migliorabile, sta a significare che le condotte sanzionabili devono comunque realizzare un’istigazione idonea in concreto a rappresentare l’anticamera di atti di discriminazione. È vero che una lettura costituzionalmente orientata delle previsioni introdotte, interpretate alla luce dell’art. 21 della Costituzione avrebbe portato comunque verso questa interpretazione; d’altra parte, inserire espressamente all’interno del testo normativo una clausola di questo tipo può contribuire ad arginare le preoccupazioni di chi ritiene che sulla base di questa legge potrebbe domani essere sanzionato chi si esprime politicamente, ideologicamente, contro la maternità surrogata, il matrimonio egualitario o chi esercita la propria libertà di insegnamento.
Nonostante tale integrazione le destre continuano a presentare il testo come legge bavaglio o legge liberticida. Ma quando un’opinione non è più legittima sì da andare al di là del diritto costituzionalmente difeso di manifestare liberamente il proprio pensiero?
Nel nostro ordinamento la libertà di manifestazione del pensiero è disciplinata dall’art. 21 della Costituzione che la tutela in tutte le sue forme e strumenti di esercizio, stabilendo un unico limite espresso, quello del buon costume, un concetto vago ed estremamente variabile nel tempo, che è oggi interpretato essenzialmente come protezione del pudore sessuale, in particolare con riferimento ai minori. In realtà, nonostante l’art. 21 affermi un unico limite esplicito alla libertà di espressione, altri limiti sono stati costruiti dal legislatore nel bilanciamento con altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti. Basti pensare ai limiti derivanti dalla tutela della riservatezza, dalla protezione dei dati personali, dalla preservazione della sicurezza dello Stato, dalla tutela dell’onore e della reputazione delle persone (in cui trovano fondamento i reati di ingiuria e di diffamazione, che limitano evidentemente la libertà di manifestazione del pensiero ma sono legittimi). Se poi si amplia lo sguardo al sistema del Consiglio d’Europa, si constata come la libertà di espressione tutelata dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non ha impedito alla Corte di Strasburgo di dar vita a una giurisprudenza molto forte nel contrasto al razzismo e alla xenofobia, tanto da “orientare” l’adozione già nel 2008 di una decisione quadro a livello europeo sulla lotta contro razzismo e xenofobia attraverso il diritto penale.
L’art. 10, c. 2 della Cedu stabilisce che l’esercizio della libertà di espressione possa essere sottoposto a condizioni o restrizioni a condizione che siano previste dalla legge e che “costituiscano misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”.
La Corte su questa base ha nel tempo costruito una giurisprudenza particolarmente attenta al valore della protezione della dignità umana, sottolineando la preminenza della protezione dell’onore, della reputazione e dei diritti altrui anche rispetto alla manifestazioni del pensiero odiose, discriminatorie, negazioniste; è proprio la giurisprudenza della Corte Edu che nel tempo ha costruito un modello europeo di bilanciamento tra libertà di espressione, eguaglianza e dignità umana.
Guardando ai temi che qui ci interessano, proprio un mese e mezzo fa la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino islandese, in quanto non costituirebbe violazione della libertà di espressione la condanna penale dello stesso per avere formulato commenti denigratori verso le persone omosessuali durante una trasmissione radiofonica.
In ogni caso quello che voglio evidenziare è che il legislatore italiano già in passato ha operato un bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della dignità umana, dell’onore, dell’eguaglianza, introducendo fattispecie che hanno ad oggetto la propaganda e l’istigazione a commettere atti di discriminazione fondati sull’appartenenza razziale. L’approvazione di questa legge amplierebbe l’elenco dei motivi di discriminazione che rilevano ai fini dell’art. 604-bis del codice penale che già punisce la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, dunque si limiterebbe ad integrare un impianto normativo esistente colmando un’evidente lacuna. Non si vede infatti perché l’elemento etnico-razziale o religioso dovrebbe assumere una rilevanza superiore o meritare un riconoscimento normativo che sesso, orientamento sessuale e identità di genere non meriterebbero. Dal mio punto di vista chi critica questa proposta di legge dovrebbe contestualmente proporre l’abrogazione delle disposizioni vigenti, di tutte quelle che intersecano la libertà di opinione e, insieme, individuare con chiarezza le strade, alternative al diritto penale, più adeguate e efficaci per lo sradicamento della visione patriarcale, maschilista e xenofoba che sta alla base di tutte le forme di discriminazione citate, e permea ancora con forza la nostra società.
Uno degli altri punti nodali del ddl è quello relativo all’identità di genere, circa la quale (al pari di sesso, orientamento sessuale e genere) il relatore Zan ha già annunciato che nel testo sarà inserita la relativa definizione come richiesto dal Comitato per la Legislazione della Camera. Ma l’espressione non è già presente nel nostro ordinamento e in quello europeo?
Trovo l’insistere su questa questione dell’“identità di genere” poco fondato. Non c’è dubbio che il diritto penale debba rispettare il principio di determinatezza, e meno lo rispetta più trascende nel diritto penale simbolico, cioè nella produzione di norme penali che servirebbero più che altro a comunicare dei messaggi, a “pedagogizzare” la società: questo significa che il legislatore deve elaborare le norme penali in maniera particolarmente chiara e precisa, non utilizzare definizioni ambigue, o termini privi di un significato univoco.
Il punto quindi è se l’espressione “identità di genere” sia sufficientemente chiara e univocamente interpretabile. Io non avrei molti dubbi: a partire dalla sentenza n. 221 del 2015 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha definitivamente sancito l’obbligatorietà degli interventi chirurgici per la rettificazione del sesso anagrafico, modificando la giurisprudenza precedente e valorizzando il diritto all’autodeterminazione della persona, il termine “identità di genere” diventa un concetto giuridico. Nella sentenza n. 180 del 2017 la Corte, richiamando il suo precedente del 2015, rileva come “l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz’altro espressione del diritto al riconoscimento della identità di genere”. Se dunque l’identità di genere è conosciuta e riconosciuta dalla Corte costituzionale, non ritengo opportuno rimuovere questo riferimento dalla legge, come alcuni/e hanno proposto, essendo essa evidentemente configurabile come l’identificazione che il soggetto opera di sé dal punto di vista del genere, quando tra questa identificazione e il sesso anagrafico sussiste una discrasia. E forse anche l’inserimento di una definizione ulteriore all’interno del testo potrebbe non essere necessario. A dirla tutta, risultano meno chiari i concetti di razza ed etnia, presenti all’interno delle stesse disposizioni legislative che verrebbero modificate (il primo peraltro, com’è noto, inesistente, tanto che addirittura da più parti è stato proposto, negli ultimi anni, di cancellarlo dal testo costituzionale).
Il ddl prevede anche misure di contrasto e prevenzione alla misoginia. A fronte delle reazioni anche di parlamentari e alcune femministe, come giudica questa scelta fortemente voluta da Laura Boldrini e Giusi Bartolozzi?
Le discriminazioni che si fondano sul sesso costituiscono la radice di tutte le altre forme di discriminazione, e così l’odio misogino rappresenta lo schema a partire dal quale si sono strutturate nel tempo tutte le altre manifestazioni di odio indirizzate verso la diversità, intesa come inferiorità. Tutte queste discriminazioni sono caratterizzate da un comune linguaggio oppressivo fatto di asimmetrie di potere e subordinazione; la matrice comune delle discriminazioni a cui si fa riferimento nella proposta, che è quella sessuale appunto, garantisce coerenza complessiva a mio avviso. Non introdurre un riconoscimento esplicito anche dell’odio misogino sarebbe stato irragionevole anche dal punto di vista costituzionale, considerato che il sesso è il primo dei fattori menzionati nel generale divieto di discriminazione contenuto all’art. 3 della nostra Costituzione.
Un’altra obiezione ricorrente al ddl riguarda la presunta inutilità della norma, dal momento che il nostro ordinamento prevederebbe già il perseguimento penale di condotte violente e discriminatorie. Che ne pensa?
Non credo che il diritto penale sia lo strumento più adatto a scalfire questo sistema, e ad evitare che come sta accadendo in altre parti d’Europa e del mondo si compiano gravi passi indietro nel riconoscimento e nella tutela dei diritti fondamentali, ma mi sono ormai convinta che il silenzio in questo momento rappresenterebbe comunque una forma di accettazione, anche perché, come ho già sottolineato, lo strumento penale è già utilizzato nel nostro ordinamento per finalità antidiscriminatorie. Da questo punto di vista dunque il ddl Zan colmerebbe una lacuna. Non c’è dubbio che si tratterebbe soltanto di un passo verso un’effettiva, profonda trasformazione dell’attitudine patriarcale che ancora permea il nostro tessuto sociale (e giuridico), ma non farlo avrebbe probabilmente conseguenze più rilevanti.