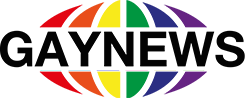Francesca Romana Recchia Luciani, ordinaria di Filosofie contemporanee e Saperi di genere presso l’Università di Bari Aldo Moro, dirige la collana della casa editrice il melangolo “Xenos. Filosofia, fenomenologia e storia dell’alterità” e co-dirige “Post-Filosofie. Rivista di pratiche filosofiche e di scienze umane”. Dalla prima edizione (2012) dirige inoltre il Festival delle Donne e dei Saperi di genere a cadenza annuale.
Francesca Romana Recchia Luciani, ordinaria di Filosofie contemporanee e Saperi di genere presso l’Università di Bari Aldo Moro, dirige la collana della casa editrice il melangolo “Xenos. Filosofia, fenomenologia e storia dell’alterità” e co-dirige “Post-Filosofie. Rivista di pratiche filosofiche e di scienze umane”. Dalla prima edizione (2012) dirige inoltre il Festival delle Donne e dei Saperi di genere a cadenza annuale.
Oltre alla violenza di genere, cui ha dedicato numerosi saggi e interventi, altro suo ambito di ricerca è l’ermeneutica della Shoah, che coltiva anche organizzando annualmente con il corso di Storia e Didattica della Shoah presso l’ateneo barese, giunto alla VIII edizione. La sua ultima pubblicazione su questo tema è Il racconto della Shoah per il XXI secolo. Testi, testimonianze, film (Progedit, Bari 2020).
È inoltre appena uscita con la sua curatela per la casa editrice il melangolo una raccolta di testi di Simone Weil: Filosofia della resistenza. Antigone, Elettra e Filottete (con traduzione di Alasia Nuti). Su questo libro e su altri aspetti della sua ricerca Gaynews le ha posto alcune domande.

Professoressa, può parlarci della scelta di un tale testo e di come esso si colloca negli studi weiliani che porta avanti da anni?
Le mie riflessioni weiliane hanno un andamento ondeggiante, fluviale, o meglio, torrentizio. Sin dal 1995, anno in cui ho pubblicato in italiano la traduzione del volume di Peter Winch, Simone Weil “La giusta bilancia”, con una lunga introduzione che ha rappresentato il mio primo saggio a lei dedicato, questo torrente (mi piace pensare a una vena aurea) a volte si inabissa percorrendo strati più profondi, e quando riemerge sono pronta per un nuovo corpo a corpo con la sua scrittura, con le sue intuizioni, con le sue idee e con tutto quanto di straordinario ricevo ogni volta che la leggo, o la rileggo. Filosofia della resistenza giunge per me, a venticinque anni di distanza da allora, come un appello, un richiamo che mi consegna una definizione capace – mi sembra – di condensare il suo filosofare intorno alle cose del mondo, intorno alla realtà amata con passione, intorno agli incontri reali e sognati della sua vita, con sintetica efficacia. È stata una filosofa resistente, anzi ha fatto della resistenza alla sventura, alla miseria ontologica connaturata alla condizione umana, la sua filosofia: l’identificazione con Antigone ci parla anche di questo. Simone Weil è essa stessa un’eroina tragica, o almeno lo è per me. Un’eroina dell’amore spassionato per gli ultimi e per Dio (che a lei sembra poi un’unica forma d’amore), il cui impegno era costantemente rivolto ad alleviare la pena dell’oppressione subita dagli umani, sottomessi alle necessità naturali e a quelle sociali.
Nel Quaderno III Simone Weil parla di omosessualità. Nelle lettere alla madre si firmava con “tuo figlio Simone”. Questi ovviamente sono solo spunti per invitarla a dirci qualcosa su Simone e il genere. Come si possono collocare questo corpo e questa mente rispetto alla nostra sensibilità contemporanea su certe questioni?
La questione del corpo e della fisicità cui la nostra materia corporea ci “inchioda”, per riecheggiare Lévinas, è centrale per Weil, ma viaggia nel sottotesto delle sue riflessioni, come una nota più bassa, ma continua, che sottende le sue composizioni. Il prossimo libro che dedicherò a Weil, un’altra raccolta di saggi, si intitola Pensare col corpo. È quello che lei fa, non pensa il corpo, ma pensa col corpo. Per questo non è facile rispondere estrapolando una teoria della sessualità o del “genere” dalla miniera preziosa dei suoi appunti: l’unica possibilità è cogliere quei passaggi in cui lei vi riflette, sempre a partire dalla propria esperienza personale, dalla propria vita, attraverso un esercizio autoriflessivo, spesso scabroso, impietoso verso se stessa, che è anche una forma di meditazione che prende forma scritta. E il corpo c’è. A volte lei preferirebbe volentieri farne a meno, ma il corpo c’è e si materializza sotto forma delle sue insopportabili emicranie, oppure attraverso metafore illuminanti. Questa per esempio: il dolore che avverte la mano dopo aver trascritto per ore testi in lingue straniere perlopiù antiche, il greco o il sanscrito, viene letto da lei come il segno che quelle lingue la stanno attraversando e che solo così possono essere apprese. Non solo per le circostanze storiche, ma più ancora per le proprie scelte personali e le proprie inclinazioni esperienziali, com’è riportato dalla sua biografa Simone Pétrement, Weil considerava indubbiamente l’essere nata donna una “singolare sfortuna”.
C’è un aneddoto sulla vita di Simone Weil che incontra Simone de Beauvoir. Ce ne vuole accennare?
In Memorie di una ragazza per bene Simone de Beauvoir sembra davvero rammaricarsi di non aver stretto un legame più intenso con la sua intelligentissima compagna di studi in Sorbonne per via – così si esprime – della propria ostinazione a “subordinare le questioni sociali alla metafisica e alla morale”, cosa chiaramente inammissibile per Weil che diffidava delle astrazioni comunque si manifestassero, alla quale la jeune fille rangée, la “ragazza per bene”, finì per invidiare “un cuore capace di battere all’unisono con l’intero universo”. L’aspra conversazione riportata nelle Memorie testimonia di una diversità di atteggiamento verso se stesse e soprattutto verso l’umanità inassimilabile, incommensurabile, radicalmente incompatibile. Ciò che realmente separava le due Simone era l’attitudine relazionale: tanto de Beauvoir ambiva ad affrancarsi dalla borghesia cui apparteneva per essere se stessa, quanto Weil, che disprezzava fino all’eccesso il ceto borghese in cui si era trovata a nascere, aspirava a quell’approccio sub specie aeternitatis che le avrebbe finalmente consentito di afferrare con pienezza e purezza la realtà, soprattutto degli esseri umani colpiti dalla sventura. Altrove ho definito questa peculiare predisposizione weiliana a sprofondare completamente nella miseria delle cose umane un’ascesi intramondana in senso weberiano, sorretta da un amor intellectualis Dei, una “conoscenza del terzo grado” di tipo spinoziano.
Esisteva in nuce una dimensione femminista in Simone Weil? Se sì, come si articolava secondo lei?
Simone Pétrement racconta come Weil abbia perentoriamente rifiutato la definizione di femminista, e sicuramente tale posizione va collocata storicamente e letta nel contesto politico, sociale e culturale dei difficilissimi anni Trenta del Novecento, in cui la percezione del crollo generale dell’umanità e di fine della storia, che culminerà nell’esplosione della Seconda guerra mondiale, deve essere stata veramente opprimente e sufficiente per lei per avvertirne la portata “universalistica”. Va detto tuttavia che la ricezione, soprattutto italiana, del suo pensiero è stata fortemente segnata dalla lettura femminista, basti pensare soprattutto alle intense ricerche che Angela Putino le ha dedicato e all’indagine genealogica attraverso cui il pensiero della differenza ha rinvenuto in lei una “madre spirituale”, al punto che il titolo del libro che avvia quel percorso teorico e politico, Non credere di avere dei diritti(1987), è una citazione dai quaderni weiliani. Altrove, nella letteratura francese e internazionale, non troviamo quella piegatura ermeneutica, dopodiché io credo che sia assolutamente legittima, anzi doverosa, una lettura “sessuata” di un pensiero così fecondo, già costitutivamente aperto a intercettare le istanze di chi subisce l’oppressione e si trova in condizioni di subalternità, situazioni che hanno caratterizzato l’esperienza delle donne sin dagli albori della cosiddetta civiltà.
Sono usciti quasi in contemporanea i suoi due ultimi libri, Filosofia della resistenza e Il racconto della Shoah per il XXI secolo. Testi, testimonianze, film, che testimonia nuovamente il suo interesse per il genocidio ebraico che, come Weil, è un soggetto ricorrente delle sue ricerche. Ci sono dei nessi? Come si intrecciano questi interessi nei suoi studi su questi temi?
L’ultimo capitolo della mia monografia dedicata alla filosofa francese, Simone Weil. Tra filosofia ed esistenza (2012), si intitola “La vita informe: Simone Weil e il vaticinio della Shoah”. Lei muore all’età di trentaquattro anni ad Ashford, nell’esilio inglese, il 24 agosto 1943, dunque ben lungi dai luoghi dello sterminio ebraico che in quello stesso tempo si sta compiendo diffusamente sui territori nazificati dell’Europa orientale, eppure in lei, ebrea “desiderosa di farsi cattolica”, l’idea del male infinito, indicibile, capace di rendere “la vita informe”, è nitida nella sua brutalità. Già nel 1934, nei Quaderni, appunta in una nota una considerazione sulla paradossalità d’ogni “sterminio [che] sopprime la potenza sopprimendone l’oggetto”, ma è soprattutto nel 1942 che si sofferma, in due saggi luminosi, sulla storia del tragico sterminio degli Albigesi che annientò, insieme all’eresia catara, la tradizione del racconto cavalleresco. Quella cancellazione nel XIII secolo della civiltà d’Oc, che incarna per lei la distruzione totale di una cultura centrale per la civiltà mediterranea, provocata dalla forza capace di produrre un male insieme estremo e superficiale, come ebbe a definirlo Hannah Arendt, e che ha imposto con “una specie di onnipotenza, la distruzione in un istante di secoli accumulati”, mi è apparsa come la più lucida premonizione del genocidio ebraico che in quegli stessi anni insanguina l’Europa provocando nel suo corpo una ferita mai più rimarginabile. Vaticinio della Shoah che solo uno spirito dalla sensibilità quasi sovrumana poteva presagire.