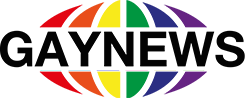In memoria di Sami Haven e Yaser Murtaja
In memoria di Sami Haven e Yaser Murtaja
«È un piccolo pezzo d’Italia nel cuore della vecchia Amman. Offrono un piccolo menu stagionale e utilizzano i migliori ingredienti locali». A definire così Jasmine House Art & Food, il 28 febbraio scorso, sul New York Times è stata la stilista Nafsika Skourti che l’ha indicata tra i cinque posti da visitare nella capitale giordana.
Ideata da Vincenzo Fullone a Gaza nel 2013 durante una passeggiata notturna dopo un bombardamento col fotografo Sami Haven (morto tragicamente il 10 marzo 2016) e il giornalista Yaser Murtaja (ucciso il 6 marzo 2018 da un cecchino israeliano mentre stava documentando le proteste del 2° venerdì della Marcia del ritorno al confine della Striscia), Jasmine House è stata aperta, l’anno successivo, nel centro storico di Amman dopo l’addio alla città palestinese.
Contrariamente a quanto fa pensare il New York Times, non si tratta propriemente di un ristorante ma di una casa, esemplata su quelle italiane degli anni ’50, quando, come sottolinea Vincenzo a Gaynews, «sulle tavole venivano messe le zuppiere, da cui tutti, in ottica condivisa, assumevano i pasti. Alla riscoperta, dunque, di una condivisione reale in tempi in cui a regnare è quella virtuale sui social network. La nostra esperienza è questa: noi mettiamo a disposizione le nostre tradizioni, il nostro cibo. È una casa, appunto, sulle cui mura gli artisti locali (pittori e fotografi) espongono le loro opere. La massima di Jasmine House, una sorta di regola spirituale, è quella che si può leggere sull’architrave della porta d’ingresso: Experience your senses. Sperimenta i tuoi sensi».
E i suoi sensi Vincenzo li ha sperimentati tutti, nel bene e nel male, nel suo cammino esistenziale, simile, per certi versi, a un romanzo.
Nato il 13 agosto 1972, Vincenzo Fullone ha 47 anni e da sette vive in Medio Oriente. Di lui s’è parlato a lungo sui giornali e in tv quando, 14enne, disse di vedere la Madonna. Anche Enzo Biagi si recò a intervistarlo, spingendosi fino a Crosia, piccolo comune del Cosentino appartenente all’arcidiocesi di Rossano-Cariati. In quel remoto angolo dello Stivale giunsero tra il 1987 e il 1994 centinaia di migliaia di persone alla ricerca di serenità, gioia, forza.
Il mondo ecclesiastico s’interessò ben presto all’adolescente calabrese. Cardinali, vescovi, sacerdoti lo incontrarono e ne rimasero conquisi a partire dall’arcivescovo locale, Serafino Sprovieri. Vincenzo fu oggetto di visite mediche e d’analisi da parte di teologi di fama come René Laurentin, che ne rimase favorevolmente colpito. Nel 2015 si tornò a parlare di lui, quando fu realizzato il docufilm Vincenzo da Crosia, in cui egli stesso narra del dramma degli abusi all’età di cinque anni, delle esperienze mariofaniche, delle stimmate.
Poi il cammino seminariale impostogli dalle autorità ecclesiastiche, che vedevano per lui nel sacerdozio un epilogo naturale di quanto vissuto a Crosia. Cammino interrotto nel febbraio 2000 per intervento dell’allora segretario della Congregazione per l’Educazione cattolica, che «dal successore di Sprovieri a Rossano – ricorda Vincenzo – aveva ricevuto un dossier su di me. 4 ex tossicodipendenti, avevano dichiarato d’aver fatto sesso con me. E non era vero. Non mi fu data nessuna possibilità di difesa. Gli altri amici, che erano in seminario, furono posti davanti a un aut-aut: o me o sacerdozio. Ritenevano che io li plagiassi. Ma essi hanno preferito abbandonare il cammino di formazione. Ho capito che la mia strada era stata tracciata e che dovevo subito scendere in piazza. “Mi state dicendo che sono gay – mi sono detto – e io vado coi gay”. Ho partecipato al grande Pride del 2000 ed è iniziato il mio impegno nell’ambito Lgbti. Impegno, che è durato fin circa al 2005».
In quell’anno il giovane calabrese comprende che quel tipo di battaglia non gli dava «tanto. Era superato. Non mi piacevano alcuni aspetti troppo politicizzati del movimento e un certo perbenismo borghese di taluni esponenti. L’ho capito anche grazie all’incontro casuale con Sami Haven, venuto dalla Giordania a Roma. Mi sentivo chiamato a un impegno verso i diseredati, gli immigrati, gli ultimi. In realtà i messaggi continuavano a farmi da guida. Lei aveve sempre parlarto di diseredati e d’ingiustizia. E quale situazione più ingiusta di quella palestinese? Così nel 2013 ho deciso di andare a Gaza e vi sono stato otto mesi».
A seguirlo è il suo compagno Alessandro, con cui Vincenzo si sarebbe unito civilmente a Napoli il 15 ottobre 2016 e da cui si è separato lo scorso anno.
«A Gaza – continua Vincenzo – la situazione stava precipitando e i nostri amici non volevano che restassimo lì. Loro hanno bisogno di noi fuori e non dentro. Usciti da Gaza, non ho potuto più sopportare questo modo di vivere all’occidentale: vuoto e caratterizzato da finte lotte. Mi sono così trasferito ad Amman, dove vivo e lavoro in quella casa che, affittata da Salwa, la madre di Sami, è oggi Jasmine House».
E con Salwa, madre addolorata per la morte del figlio, immagine vivente di quella madre che Vincenzo disse di aver visto piangere in una chiesina abbandonata di Crosia nel maggio del 1987, l’attivista e chef calabrese ha inaugurato, in dicembre, presso l’ambasciata d’Italia ad Amman la Settimana della cucina italiana nel mondo.
«Oggi Jasmine House – così Vincenzo su Facebook il giorno stesso dell’evento – è sinonimo d’Italia in Giordania. Io e Salwa questa sera, in ambasciata d’Italia, abbiamo inaugurato la Settimana della cucina italiana nel mondo con i rappresentanti diplomatici di mezzo mondo: chi lo avrebbe mai immaginato quella sera del 23 novembre a Gaza. Ho seppellito i miei santi, ho chiuso con i miei fantasmi ed oggi ad Amman ho un nome diverso: Vincenzo di Jasmine House».