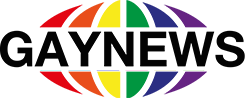Non è facile sintetizzare quanto Bruno Tommassini sia stato fondamentale nella storia del movimento Lgbt italiano ed è altrettanto difficile riassumere la sua poliedrica personalità e attività, anche elencando i tanti incarichi: presidente della Federmoda Toscana, membro della segretaria di Gaynet, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Arcigay nazionale e amministratore delegato di Prodigio Divino, giusto per rimanere nel presente.
Non è facile sintetizzare quanto Bruno Tommassini sia stato fondamentale nella storia del movimento Lgbt italiano ed è altrettanto difficile riassumere la sua poliedrica personalità e attività, anche elencando i tanti incarichi: presidente della Federmoda Toscana, membro della segretaria di Gaynet, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Arcigay nazionale e amministratore delegato di Prodigio Divino, giusto per rimanere nel presente.

Grillini, se permetti, aggiungerei anche “gran Marchesa delle Vignacce”. Sia chiaro, ai titoli nobiliari non ci si crede più, ma utilizzati bene servono a non prendersi troppo sul serio.
Allora, cara Marchesa, noi ci siamo conosciuti a Bologna negli anni Ottanta. Qual è stato il tuo impatto con il Cassero? Cosa ti ricordi di allora?
Tutto. Avevo visto su Oggi la tua foto con Beppe Ramina. Allora soffrivo di un indefinibile disagio sociale e lamentavo una sostanziale assenza di iniziativa, sia nostra che della classe politica. Le storie che venivano da Bologna mi incuriosirono e insieme mi diedero una speranza. Presi il treno e mi recai al Cassero. Nella mente riesco ancora a ricostruire – con un filo di nostalgia – la mitica sede di Porta Saragozza. Entrando, a destra, c’era la sala principale, a sinistra il bar, sopra la biblioteca. Dentro era tutto un fermento e io venni a cercare te. E, diciamocelo, non fu difficile trovarti visto che, praticamente, tu eri sempre lì. Non ricordo nel dettaglio di cosa parlammo, ma solo gli argomenti generali. Ricordo anche che tornai a casa con non so quale felicità in cuore e qualche numero dei Quaderni del Cassero fra le mani. Sul treno mi misi a leggere. C’era una prefazione della senatrice Lidia Menapace che divenne – nel corso del tempo – il mio “credo”.
Cosa ti colpì di quel testo?
Ti dirò, non tanto il contenuto in sé quanto il fatto che a scrivere certe cose non era un gay come me ed era perfino una persona politicamente ben incardinata, in un momento in cui le istituzioni – anche da sinistra – spesso ci snobbavano. Ricordo anche di aver letto uno scritto di Gianpaolo Silvestri – ex senatore dei Verdi e inventore del simbolo dell’Arcigay – che parlava di cose per le quali io non ero ancora pronto. Infatti, allora ero concentrato sui miei problemi e dovevo ancora comprendere la complessità del mondo Lgbt.
Però, se non erro, ti eri dato uno scopo preciso…
Certo. Dopo essere venuto più volte a Bologna, mi proposi di dare vita all’Arcigay di Firenze. Furono in due ad aiutarmi: il caro Amos Cecchi, allora dirigente della Fgci e del Pci, e Riccardo Nencini, ora senatore della Repubblica. Nencini mi diede 500.000 lire del suo partito. Onore al merito: il Psi di allora finanziava Arcigay. Con Nencini rimanemmo in contatto, con un rapporto umano e una stima reciproca che dura anche oggi, nonostante il lungo tempo trascorso e posizioni politiche non sempre coincidenti. E io non scordo mai chi mi ha fatto del bene…
Erano tempi duri a sinistra, hai ragione. Cosa ricordi della tua esperienza nel Pci?
Tantissime cose, ma tra queste ce n’è una degna di nota. Andai al congresso provinciale del partito. Io non avevo né tessera né niente, ma chiesi di poter parlare. Cecchi mi fece dare la parola. La sintesi del mio intervento è racchiusa in un passaggio molto diretto che ricordo ancora: “Ma che partito del cacchio è questo? Voi parlate di diritti ai gay e non sapete manco quanti segretari di sezione sono omosessuali”. In realtà non lo sapevo neppure io – solo dopo venni a sapere che ce n’erano veramente! – ma in qualche modo sortii dei risultati. La segreteria federale prevedeva dieci componenti. Il presidente dell’assemblea del comitato federale chiese che fosse composto da “dieci persone più una”. In pratica mi stavano cooptando ma era troppo difficile dire “undici”? Insomma, avevo ottenuto qualcosa ed ero allo stesso tempo infastidito per quel goffissimo “più uno”. Decisi di rinunciare, ma quel posto venne ricoperto dal Cioni che, qualche anno dopo, promosse una delibera per le unione civili al Comune di Empoli. L’iniziativa fu bocciata dal Co.Re.Co. – posso dire che non provo rimpianti per questo organo di controllo? – ma poi si trasformò nella prima proposta di legge a Montecitorio per le unioni civili, alla fine del 1993.
E infatti molti ti ricordano pasionario sostenitore di Graziano Cioni candidato sindaco al Comune di Firenze.
Ah sì! Inventai perfino uno stornello in cui si invitavano le leggiadre signore fiorentine ad affacciarsi alle loro finestre per sostenere il Cioni. Ma poi, alle primarie, la spuntò il Dominici.
Facciamo un passo indietro, raccontaci il tuo coming out.
Io non lo feci mai. Parliamoci chiaro: ero tutt’altro che una velata… Per certi versi, la mia è una storia incredibile. Quando avevo tredici anni ero già fidanzato con uno. La mia situazione era chiarissima a tutti, confusa solo per chi non avesse voluto credere ai propri occhi: uscivamo, ci tenevamo per mano e in paese avevano iniziato a chiamarmi “Brunino”. L’ho capito molto tempo dopo che in quel diminutivo c’era già anche quella punta di perfidia paesana con cui certuni mi apostrofavano con commenti impietosi. Quegli stessi che, ancora oggi, a persone più fragili potrebbero creare disagio e sofferenza. A tale proposito ci sarebbero mille aneddoti da raccontare, ma li riassumo tutti con quello di un cameriere che ex abrupto, durante un pranzo, platealmente mi chiese: “Signorina, vuole ancora piselli?”. Il mio amico Valter, che veniva a scuola con me, ancora lo racconta. A quindici anni andai a Roma con il mio ragazzo che ne aveva diciotto. Il suo babbo e la mia mamma si incontrarono e decisero di non fare nulla: occhio non vede, cuore non duole. Fummo ospitati da una ragazza più grande – chiaramente lesbica, ma questo era un dettaglio chiaro a me e non certo ai miei – che rassicurò i nostri genitori. Invero ero magrissimo, appena cinquantadue chili, avevo lunghi capelli neri e i fans – chiamiamoli così – mi avevano dato il nomignolo di “capinera”. I problemi vennero poi.
In che senso?
Nel senso che a un certo punto capii che quella storia non aveva alcuna possibilità. Ci lasciammo e il ragazzo si sposò. Non me la sento di giudicare chicchessia, ma a me sembrava inseguisse la chimera di una vita “normale” mentre io volevo una vita piena, e soprattutto non volevo che quello che avevo vissuto fosse minimizzato e ridotto a un banale gioco. Lui non era pronto per accettare quella sfida, io mi ci buttai. Non fu tutto semplice e lineare: ebbi anch’io dei momenti di confusione e confesso di aver sentito qualche volta la sirena di una ipocrita e superficiale normalità. Iniziai ad avere due, anche tre donne contemporaneamente, e la mia sessualità divenne un groviglio disordinato. Ma alla fine prevalse altro. Quello che più desideravo era progettare la mia vita con un uomo e, di fondo, una maggiore trasparenza nei rapporti umani. In cinque paroline: volevo la luce del sole. Ecco, io ero – e spero di essere ancora – così, e questa voglia di non rimanere nell’ombra sarebbe ritornata in una lettera che Stefano Rodotà mi pubblicò su Repubblica: la scrissi che erano passati già quindici anni da quando mi ero messo con Edoardo. E come noi, c’erano tante coppie gay e lesbiche che chiedevano un riconoscimento.
Torniamo alla fondazione del circolo dell’Arcigay. Quanto durò e perché finì la tua presidenza?
Non ricordo precisamente quanto durò. C’era un certo fermento nel mondo culturale, soprattutto universitario. Forse anche un po’ sull’onda di quelli che erano in genere i modi e le strategie del post Sessantotto, molte persone avevano iniziato a percepirmi come “troppo istituzionale”, legato al partito (io!) mentre loro si sentivano intellettuali liberi e belli, sempre intenti a sottolineare il loro rifiuto verso un qualsiasi rapporto con le istituzioni. In particolare, ricordo un’associazione di lesbiche particolarmente spigolosa. Così mi inventai – come diciamo noi in Toscana – uno “sgamotto”, ovvero un piccolo escamotage: decisi di passare lo scettro all’architetto Giovanni Pacciani che conosceva bene l’Università di Firenze e soprattutto la Facoltà di Architettura, da sempre laboratorio culturale molto interessante. Comunque, lasciare la presidenza era diventata una necessità: la mia vita stava cambiando e dovevo trovare nuovi equilibri.
Oramai la tua storia con Edoardo era perfettamente consolidata…
Ti racconto solo un aneddoto. Pochi mesi dopo che Edoardo e io venimmo a vivere qui alle Vignacce – parlo di vent’anni fa – ebbi una peritonite d’urgenza. Avevamo buoni rapporti con il nostro vicinato, in particolare con una coppia di contadini in pensione: lei e lui mi vennero trovare in ospedale con dei dolcetti. La signora, con marcato accento chianino, mi disse: “Bruno torni a casa, il suo Edoardo senza lei è senza testa”.
Edoardo era uno stilista già affermatissimo. Anche tu iniziasti molto presto a lavorare per grandi griffe. Qual è stato il tuo rapporto con Prada?
In principio lavoravo per la Cna, in una organizzazione sindacale. Quando arrivai da Prada mantenni il mio modo di fare da piccola impresa artigianale. Non mi fu subito chiaro cosa fosse il sistema della moda. In pratica era un’industria, e nell’industria sei solo un numero e ti sembra di non partecipare attivamente al processo creativo che, nel nostro settore, è fondamentale. Ricordo che producevamo due milioni di borse a stagione (bada bene: non all’anno, a stagione!). Mi chiedevo spesso: ma dove cavolo vanno queste borse? Non avevo ancora capito che le donne mettono nelle borse la casa, i bambini, le scarpe…. tutto il loro mondo. Quando lo compresi, mi fu più chiaro anche il noto adagio di Della Valle: “Le donne amano indossare un tacco diciotto, ma dentro le borse nascondono il mocassino Tod’s”.
Rimaniamo su questo tema. Sei presidente della Cna Federmoda regionale che raccoglie ben 2700 artigiani e circa 400 orafi. Condividi da più di quarant’anni la tua vita con uno stilista. Secondo te, moda e omosessualità costituiscono davvero un binomio? C’è un rapporto particolare tra moda e mondo gay?
No, non lo credo affatto. Anche se sono ‘gayo’ e vivo nella moda, questo è uno stereotipo bello e buono, frutto di quella parte della moda che è solo fuffa, pure increspature di superficie di un glamourinconsistente, perché moda e stereotipi sono davvero agli antipodi. Lavorare nella moda è come fare il trattorista: non hai stop, non hai tempi, la scuola conta, ma conta molto di più la pratica, cioè la bottega o la fabbrica. Vuoi che sia più chiaro? Non si nasce stilisti allo Ied o al Marangoni, ma si diventa tali quando si inizia ad avere la consapevolezza di quanto costa fare quel lavoro che hai già nella tua mente, con una macchina a colonna o con una cucitura dritta: è un mondo fatto di vita in bottega, nel senso più rinascimentale e – se permetti – toscano del termine, di saperi molteplici, di critica interpretazione e conoscenza del mercato. Qual è la borsa più bella? Semplicemente: quella che vende di più. Si tratta di un apprendistato e di un lavoro durissimo che non c’entra nulla con l’orientamento sessuale. Faccio un esempio: tutte le domeniche Edoardo mi costringeva a girare per negozi. Sia chiaro, il suo obiettivo non era quello di copiare – semmai, un artista a volte si può cimentare in un’opera di imitazione molto complessa che meriterebbe un’analisi a sé – ma andava a vedere quello che non si doveva fare. Anche la moda, come molte arti, procede per sottrazione: capire cosa non si debba fare è perfino più importante delle idee geniali che puoi coltivare nella tua testa. E l’osservazione va allenata, guicciardinianamente bisogna avere sempre un occhio capace di critico discernimento. Ad esempio, quando salivo sul tram, le donne erano spesso turbate dal mio sguardo che cadeva sulle loro borse: forse pensavano che fossi un borseggiatore e certamente non sapevano il vero motivo di quella furtiva indagine. Lavorare nella moda è anche questo: la dimensione creativa ti toglie la percezione cronologica del tempo e non hai più orari. Si è un po’ come delle api operaie, pensiero e azione sono sempre in continuo fermento. Qualche tempo fa, il sindaco Nardella, di cui sono consigliere speciale per la moda e l’artigianato, mi chiese di invitare François Henri Pinault del gruppo Kering – che significa Gucci, Bottega Veneta e tanti altri brand del lusso – e a Pinault dissi: “Noi siamo le api operaie che teniamo in vita voi, api regine”.
Insomma, vuoi dire che conta di più l’esperienza della genetica…
Assolutamente, anche se una predisposizione per questo lavoro – che non c’entra nulla con l’orientamento – ci sarà sicuramente. Guardando alla mia esperienza personale posso affermare di essere diventato stilista nel tempo, mentre il mio compagno Edoardo lo è stato da sempre grazie a un talento raro, direi pure eccezionale. E lavorare con dei bravi maestri è comunque fondamentale per diventare veri stilisti. Io ho avuto la fortuna di poter lavorare con lo stilista e maestro pellettiere più grande del mondo – mio marito – e grazie soprattutto a lui ho imparato a indirizzare la mia creatività carpendo i segreti del mestiere.
Quale consiglio daresti a una giovane o a un giovane che volessero diventare stilisti?
Meno accademia e più bottega. In realtà è un messaggio che vorrei dare anche alla classe politica. L’apprendistato deve passare dall’economia reale e non può essere separato dallo studio. Lo stesso concetto di “alternanza scuola-lavoro” introdotto dalla Moratti con l’articolo 4 della L. 53/2003 – e poi ribadito dal successivo decreto attuativo, il D. Lgs. 77/2005, e da una pletora di iniziative del legislatore fino alla stessa L. 107/2015 – ha buoni motivi ispiratori, ma è proprio sbagliato nella sua enunciazione, perché scuola e lavoro non possono essere alternativi. Le ragazze e i ragazzi devono arrivare nelle botteghe e nelle imprese con forti competenze comunicative, con solide capacità ermeneutiche, con un bagaglio culturale importante. Insomma, non c’è arte senza studio e senza un pungolo alla formazione (e alla riqualificazione) personale e continua. Di converso, bisognerebbe riflettere su quante aspettative esagerate vengano spesso riposte da molti giovani in istituzioni accademiche, anche molto costose, che non sono perfettamente innervate nel nostro sistema produttivo. In generale, mi sembra che quest’ultime tendano a marginalizzare il lavoro dell’artigiano. Al contrario la “téchne”, che i latini chiamavano ars, nasce solo dall’esperienza quotidiana con quei maestri che ti introducono, giorno per giorno, nel mestiere e che ti aiutano ad esprimere totalmente quello che sei, a dare corpo alla tua libertà.
Non è questa anche la filosofia di Prodigio divino?
Assolutamente sì. Prodigio divino è nata come azienda per commercializzare vini di grande qualità. Il progetto, che ha mosso i primi passi tra 2001 e 2010, si è incarnato in una società fondata da me ed Edoardo nel 2011 a cui, nel 2015, si è aggiunto l’amico Fabio Canino. Alla base di tutto c’era la voglia di eccellere e di abbandonare i luoghi comuni, esattamente come nella nostra vita lavorativa e personale. Abbiamo scelto le materie prime, i vitigni, con la solita cura, abbiamo cercato di creare prodotti capaci di incarnare delle idee, di veicolare dei messaggi, oltre a un gusto raffinato. Prodigio divino è nostro e con molta più forza, pur nel nostro piccolo, abbiamo potuto rivendicare la possibilità di fare qualcosa per un mondo migliore, fatto di uguaglianza e di rispetto, anche grazie al nostro lavoro e alla nostra arte. E al messaggio abbiamo accompagnato tante attività concrete. Infatti, tutto il fatturato che eccede dai costi di produzione viene devoluto per supportare attivamente tante iniziative.
Le vogliamo ricordare?
L’elenco è lunghissimo e sicuramente rischio di non nominarne qualcuna. Vado in ordine sparso: dal Passioni Festival di Arezzo allo Youth Pride Camp dell’Arcigay, dall’associazione contro l’omofobia Maima alla Diversity di Francesca Vecchioni, no profit impegnata nel diffondere la cultura dell’inclusione (per cui, insieme al Blanco di Milano, siamo riusciti a dare vita a una borsa di studio),dal Queer Lion – il premio collaterale alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia creato da Daniel Casagrande per il “miglior film con tematiche queer”, al Mengo Music Fest e all’Istituto Agazzi, che insistono entrambi sul territorio aretino, dalla U.S. Sempre Avanti Juventus di Firenze fino alla casa di produzione Articolture per il film Zen sul ghiaccio sottile, diretto da Margherita Ferri. Tante iniziative, tante buone idee che soggetti diversi – anche grazie a Prodigio divino – sono riusciti a realizzare concretamente.
E qual è stato il feedback del mondo dell’associazionismo Lgbt verso Prodigio divino?
Mi è concesso stendere un velo pietoso? A onor del vero solo Gaynews e Matteo Cavalieri, con il Red di Bologna, si sono accorti della nostra presenza.
Eppure, Prodigio divino è diventato sempre più grande e ha diversificato le sue attività…
Sì, dai gioielli alle borse abbiamo creato una vasta gamma di prodotti e, soprattutto, cercato di valorizzare una grande quantità di energie e professionalità mortificate da una crisi del settore artigiano che non ha sempre trovato una regia efficace e risposte adeguate alla nuova sfida dei mercati. Va detto: io sono un “signor nessuno” come imprenditore della moda, ma conosco bene gli artigiani. Vorrei che molti amici lo capissero: non possiamo confrontarci con armi tradizionali con quei paesi che lavorano l’oro con manodopera a bassissimo costo. Ma grazie alla magia delle mani dei nostri orafi, abituate per tanto tempo all’oro, oggi lavoriamo anche materie prime più semplici. Ma la differenza è data dall’abilità tecnica, dalle idee, dalla ricerca continua e dalla creatività artistica: è questo il plusvalore, il quid indefinibile ma vincente che può suggerire nuove strategie per il futuro. E, ancora una volta, Prodigio divino si fa strumento per aiutare progetti importanti. Tra le tante attività, vorrei ricordare la creazione di una collezione di gioielli dedicata alla piccola Maria Sole Marras, per l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
E perché sei tornato alle borse?
Posso dire che è stata una scommessa tra me e la Cna. Io ero e sono tuttora convintissimo che in questo momento storico (il negozio di Arezzo è nato nell’autunno 2019) il distretto aretino sia in grado di fornire tutto ciò che può servire per creare una filiera come nel territorio fiorentino, da sempre vocato a questo tipo di attività. E creare una filiera significa ordinare una aggregazione di saperi, un circuito virtuoso fatto di una comunicazione efficace e di un’organizzazione efficiente fra soggetti portatori di competenze complementari finalizzate a creare un processo di produzione comune. Il rapporto tra tradizione e innovazione si fa sempre più imprescindibile: la conoscenza e il senso di un’appartenenza culturale diventa fondamentale per trovare buone strategie in un mercato globalizzato. Nei nostri gioielli e nelle nostre borse puoi ritrovare, ad esempio, acini d’uva, pampini o i colori delle resine rosse che ricordano la nostra terra e la nostra storia. E, paradossalmente, è solo da una conoscenza profonda della tradizione che puoi attingere quelle idee e quelle forze utili per liberarti della tradizione stessa. Lo so, siamo nati in un momento difficilissimo ma, nonostante il lockdown, abbiamo le forze per guardare al futuro. La nostra filiera, infatti, ha radici profonde e rami che si allungano lontanissimi. Mi spiego meglio: il nostro lavoro verrà promosso da una piattaforma di internazionalizzazione che si ramificherà anche in mercati lontani, come la Cina. Anzi, siamo stati selezionati proprio dalla Repubblica Popolare Cinese come servizio di e-commerce del lusso.
Ecco, lo hai citato tante volte ma mi sembra importante che tu ci racconti come sono stati questi anni vissuti con Edoardo.
Sono stati quarantatré anni pieni, belli, con tutto quello che la vita ci ha dato, dalla felicità alla morte dei nostri genitori che abbiamo avuto la fortuna di accompagnare fino alla fine. A Edoardo devo molto. Da lui ho imparato la semplicità, l’onestà (sì, perché l’onestà si può imparare) e la chiarezza. Sono più innamorato ora di tanti anni fa. Ogni notte metto la mano sotto le sue mutande e gli tocco la chiappa, la mela destra detta “Ernesta”.
Perché vi siete sposati?
Lo eravamo già, di fatto, il matrimonio come progetto di vita c’era da tanto tempo. Io ed Edoardo abbiamo costruito tante cose. Oltre alla discriminazione del mancato riconoscimento, la cosa che mi urtava era la mancanza di garanzie e di tutele. Io non ho eredi, lui ha quattro fratelli e relativi nipoti, che sono anche i miei cognati, le mie cognate e i miei nipoti. A dire il vero abbiamo deciso di sposarci all’improvviso. Era il 2016 ed eravamo in vacanza a Malta. Fummo avvertiti che il governo Renzi rischiava di cadere da un momento all’altro e, in assenza dei decreti attuativi, era necessario sposarsi subito. Chiamai il sindaco di Marciano e la cosa si fece in fretta e in furia. Eppure, praticamente tutto il paese venne alla nostra celebrazione. Credo fosse stato il verduraio ad aver detto a tutti che io ed Edoardo ci saremmo sposati alla Torre di Marciano della Chiana. Durante la celebrazione, il mio sindaco, Marco Barbagli, mi chiese di dire due parole e io gli risposi con una punta di scherzo salace, tipicamente toscana: “Sono contento che tu, alla fine, mi abbia sposato”. Ma fu il senatore Cerno, nostro testimone di nozze, a tenere il discorso e che, per volontà nostra, dedicò il matrimonio a una persona molto speciale: il nostro amico Franco Grillini senza il quale – disse Tommaso Cerno, sollevando un plauso generale – l’Italia sarebbe rimasta indietro di secoli.