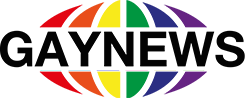Sono stati moltissimi gli articoli in ricordo di Lidia Menapace, che ci ha lasciato lunedì 7 dicembre. E anche molti i ricordi sui tg di tutte le reti, che ne hanno ciato le ultime interviste a Gad Lerner sulla sua attività di staffetta partigiana (“Partigiani lo si è per tutta la vita”) e a Giovanni Floris nel febbraio scorso. Lidia era una giramondo, andava a tutte le iniziative dove la invitavano, anche a 96 anni, con la caratteristica che la distingueva: prendeva il treno (non so se ha mai preso un aereo in vita sua), faceva il dibattito e poi tornava nella sua Cles, in provincia di Trento, il paese d’origine del marito Nene.
Non parlava volentieri del suo privato. Ma del fatto che il “privato è politico” sì, eccome! Il tratto distintivo della politica di Lidia è stato proprio questo e spiace che in tutti i commenti sulla sua scomparsa ci sia stato solo un generico riferimento alla sua militanza femminista. Assai poco, invece, sul pensiero e l’attività politica, incentrati sulla rilevanza della vita affettiva e sessuale delle persone non separabile dalla politica stessa. Io ne ero già convinto fin dagli esordi della mia militanza politica nel 1971: per questo l’incontro con Lidia fu praticamente ovvio e naturale nel Manifesto prima, nel Pdup poi. Al punto tale che dentro al partito si formò una corrente di fatto che vedeva Lidia come leader: arrivammo così ad avere il 33% del Pdup con intere federazioni schierate sulle sue posizioni. Negli anni ’70 i gruppi dell’estrema sinistra, che allora si chiamava extraparlamentare (ma nel ’76 il Pdup sia pure con uno striminzito 1,65% entrò alla Camera con sei eletti), erano assieme al partito Radicale di fatto gli unici interlocutori del nascente movimento Lgbt (che allora si chiavava movimento gay).
Anche nel Pdup si formò un gruppo di militanti gay, che si riunì varie volte nelle sedi del partito di Roma, Bologna e Genova. La militanza gay era monodirezionale: dal partito al movimento come per il sottoscritto. Il mio sofferto coming out è del 1982 (poco prima dell’inaugurazione del Cassero di Porta Saragozza). Ma con Lidia fummo protagonisti di una nouvelle vague, di una rivoluzione, anche della cultura politica, che proponeva di superare quel marxismo “volgare” che distingueva in modo manicheo le famose categorie della “struttura” e della “sovrastruttura”. Alla prima appartenevano le “priorità”: lavoro, diritti sindacali, industria, sanità, infrastrutture, scuola. Alla seconda, quindi in secondo piano, tutto il resto: la lotta femminista, i diritti civili, la cultura lato sensu e i diritti delle minoranze. Non a caso, come movimento Lgbt siamo da sempre stati vittima della mancanza di cultura politica nella sinistra sui diritti individuali di libertà. Nel Manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels la libertà è declinata come libertà di classe: è quindi la classe operaia che, liberando sé stessa, libera tutta l’umanità. In questa lettura schematica del marxismo non solo non c’è spazio per i diritti individuali di libertà ma c’è addirittura un certo fastidio per chi si attardasse su questioni “sovrastrutturali” e non sui temi “veri” dell’agenda politica. Il teorico di questa distinzione fu soprattutto il filosofo marxista Louis Althusser, che ebbe grande influenza sulla sinistra europea di quel tempo.
Ecco perché, su impulso di Lidia Menapace, si formò una “corrente”, dentro e fuori al partito, di chi, come me, era invece convinto che non ci potesse essere il “pane senza le rose”, cioè giustizia sociale senza diritti civili. Con Lidia si affrontavano di petto temi negletti, a volte persino nell’estrema sinistra, come il femminismo, la lotta per la liberazione sessuale, il valore dell’autonomia della sessualità e del piacere come valore e non come riprovazione. Tutto ciò contro le ipocrisie e una certa sessuofobia di chi vedeva, per sospetto di “deviazionismo borghese”, questa militanza e queste tematiche.

Considero Lidia Menapace una delle mie madrine politiche fondamentali: posso tranquillamente dire che senza di lei, senza quelle riflessioni degli anni ’70, senza quella idea rivoluzionaria della vita privata e della sessualità, probabilmente non ci sarebbe stata la mia militanza Lgbt successiva. Ma non erano ovviamente tutte rose e fiori. Non a caso, nonostante la fetta rilevante di consensi nel partito, nelle varie elezioni parlamentari dove si presentò il Pdup (se la memoria non mi tradisce quelle del ’76, poi con la sigla di Democrazia Proletaria e di nuovo negli anni ’80 come Pdup) Lidia era collocata come candidata in posizioni che, difficilmente, avrebbero generato una sua vittoria. Le dissi da subito che il gruppo dirigente di fatto non la voleva in Parlamento: ma lei non era una che sgomitava e così finiva candidata in Calabria, quando il Pdup eleggeva a Roma e a Milano. Se si pensa che solo agli inizi degli anni ’80 il Pci iniziava a fare qualche timida apertura sui diritti civili e sulla cultura liberal e laicista a sostegno, ci si può immaginare quanto anche nell’estrema sinistra le cose non fossero così facili. Tipico, da questo punto di vista, l’episodio della Romagna, dove i militanti del Manifesto ritiravano il giornale dai bar che avevano abbonato, quando venivano pubblicati gli articoli di Giovanni Forti (poi corrispondente de L’Espresso da New York) sull’omosessualità.
L’immagine di uno dei tanti dibattiti e incontri che ho fatto con Lidia Menapace mi porta a una foto, risalente al ’79, del teatro bolognese La Soffitta, gremito di militanti e persone interessate sul tema dei diritti civili, del femminismo e del sesso. La questione centrale era: ma perché esiste la sessuofobia, quella cattolica in primis? Poi l’ipocrisia della destra e, infine, i problemi anche a sinistra. E la risposta di Lidia, da me ovviamente condivisa, era che il patriarcato e il potere maschilista volevano il controllo ferreo della sessualità (in particolare del corpo della donna) come strumento di potere e alimentavano l’odio verso gli omosessuali considerati traditori del branco. Per non parlare del piacere sessuale, visto da sempre con sospetto dalle culture repressive, che, attraverso queste riflessioni, veniva valorizzato e riproposto come fatto positivo di relazione tra le persone in autonomia dal familismo tradizionale e dall’idea che non ci potesse essere sessualità slegata dalla riproduzione.

Questo, secondo me, è il vero lascito di Lidia che ha contribuito a rivoluzionare e a proporre il privato come politico. Poi c’è stata la Lidia pacifista contro il militarismo, la Lidia antifascista come partigiana, la Lidia del sostegno alle lotte dei lavoratori. Ma la sua rivoluzione fu quella di donne e uomini che buttavano a mare il patriarcato e lo strapotere maschile: il nostro debito verso di lei è dunque veramente grande. Si può dire grazie a una persona che non c’è più? Sì, si può: e con Lidia si devono ringraziare e ì soprattutto ricordare tutte le persone che ci hanno preceduto e alle quali dobbiamo la nostra attuale libertà.