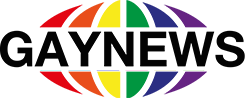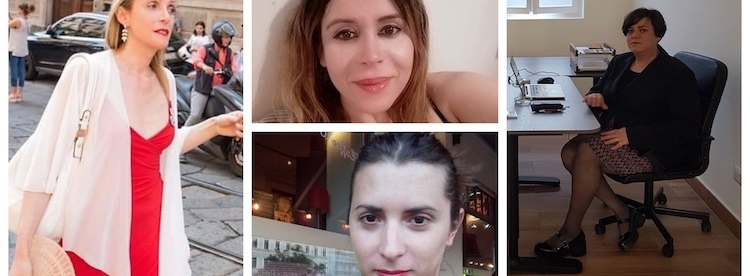
Nei giorni scorsi sulle pagine de Il Manifesto abbiamo assistito a una lunga querelle, originata da un articolo de La Repubblica. Oggetto del contendere le persone trans e il loro vissuto di presunta sofferenza perenne. Non sono mancate le repliche di attiviste/i trans, supportate anche da associazioni.
Anche Gaynews ha dato ampio spazio alla questione, che sembrava destinata a non concludersi. Il 31 luglio, infatti, sono state/i “le/gli psicanalisti buoni” a prendere la parola con un ennesimo articolo su Il Manifesto, che ha suscitato diverse reazioni a partire da quella delle tre attiviste esplicitamente menzionate: Laura Caruso, Monica Romano e Antonia Caruso.
Abbiamo, quindi deciso di contattarle per avere un commento. Tre punti di vista, i loro, a tratti simili a tratti diversi, che mettono in luce l’importanza della presa di parola da parte delle persone trans, invisibilizzate e sovradeterminate con toni paternalistici dei quali le stesse vorrebbero fare del tutto a meno.
La prima a risponderci è Laura Caruso, che insieme a Monica Romano, è stata l’deatrice della prima lettera a Il Manifesto dopo l’articolo di Sarantis Thanopulos:
In questo ultimo articolo su Il Manifesto del 31 luglio, che prosegue sul tema dell’identità di genere, ci sono alcune cose che non mi convincono.
La prima riguarda il passo “Agli/alle attivisti/e trans* indichiamo, anche a partire dalla nostra esperienza di interlocutori clinici, che le storie e le voci delle persone trans* non sempre parlano da una posizione di sicurezza e di forza come quella che traspare dalle parole delle attiviste che hanno partecipato al dibattito”.
Evidentemente la nostra posizione non è stata abbastanza chiara: vorremmo cambiare l’angolo visuale che ci pone di fronte interlocutori “clinici” per avere, finalmente, interlocutori politici. Abbiamo capito che sono “clinici”, questa qualifica, come quella di “accademici”, viene dichiarata ad ogni piè sospinto. Ci rallegriamo delle qualifiche professionali ma noi non siamo un “oggetto di lavoro”.
E anche sulla posizione di sicurezza e di forza, visto che sono una delle tre persone “sicure e forti” citate: gli autori non sempre la osservano, questa posizione? Ci ricordano quindi che esiste una moltitudine di persone che sono invece insicure e deboli? Beh, se è vero che siamo sicure e forti, spero che questo apra uno spazio di riflessione a chi non si sente così, che sorga il dubbio sull’opportunità e sulla lungimiranza di restare in una posizione di subordine.
Non mi convince, infine, l’approccio un po’ bipartisan che riconosce sì, degli errori (ma solo un po’) e ci se ne rammarica (ma solo un po’) e un po’, invece, si fa uso del “ammonisce” l’altra parte. Ecco, questo non mi convince: stare da tutte e due le parti quando queste sono chiaramente distanti.
Qui il focus delle nostre posizioni non è il “dibattito alto”: noi vorremmo semplicemente che le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità venissero accolte senza resistenze e queste resistenze ci paiono tanto più inopportune quanto più sono legate al cuore dell’attività professionale di chi le rappresenta.
Da parte sua la scrittrice Monica Romano aggiunge:
A chi afferma che le persone transgender necessitino di psichiatri, psicologi e psicoterapeuti perché “sofferenti”, rispondo che un percorso psicologico dovrebbe essere sempre la conseguenza di una scelta libera.
Probabilmente il gruppo di terapeuti, psicoanalisti e ricercatori che ha espresso il suo punto di vista sulle pagine de “Il Manifesto”, ignora che alle persone transgender, oggi in Italia, le relazioni psichiatriche e psicologiche vengono imposte. Infatti, in assenza di queste perizie non è possibile accede ai percorsi di transizione: il nostro diritto all’autodeterminazione ci è quindi precluso.
Aspetto non secondario: l’impossibilità di autodeterminarci va a vantaggio delle tasche di quegli psichiatri e psicologi – sedicenti esperti di variabilità di genere – i quali – assieme ad altre professionalità (medici, chirurghi, avvocati, operatori sociali) – hanno creato un vero e proprio sistema e indotto economico che vive su di noi.
A seguito della decisione storica dell’Organizzazione mondiale della Sanità che ha recentemente stabilito che la nostra non è una malattia mentale, sposterei quindi questo confronto dalle pagine de Il Manifesto a un carteggio con l’Ordine degli Psicologi e con la Segreteria della Presidenza del Tribunale di Milano, giusto per chiarire che l’interlocuzione è politica.
Le persone transgender hanno bisogno che il mondo e la cultura cambino, non che la loro legittima sofferenza – che certo non trova la sua origine nel “sé”, essendo causata da una cultura binaria e transfobica – venga “curata”, peraltro a fronte di laute parcelle. Insomma, scendiamo dai lettini degli psicoanalisti e volgiamo uno sguardo nuovo – oltre il velo di Maya – al contesto in cui viviamo, possibilmente mettendolo in discussione.
I dottori e ricercatori firmatari, in riferimento al posizionamento mio e di altre attiviste, hanno fatto riferimento a “posizioni di forza e sicurezza” (come se ci conoscessero), “ideologie” (capziosamente e con un certo pregiudizio), oltre che a una “espunzione di sofferenza”, come se le scriventi, nelle loro vite, non avessero mai sofferto. Con quale arroganza, io mi chiedo? Quella, con buona probabilità, di un sapere che – nell’ambito della transessualità, transgenerità e variabilità di genere – è stato, negli ultimi decenni, decisamente sopravvalutato.
Particolarmente dura Antonia Caruso, una cui lettera era stata pubblicata, sia pur in ritardo, da Il Manifesto:
Dalla lunga sequenza di articoli, lettere, risposte ad altre lettere sono emerse varie cose.
La più evidente è che anche la cultura di sinistra (sempre se vogliamo definire La Repubblica di sinistra, mentre Il Manifesto indubbiamente lo è) usa una prospettiva clinica per parlare dell’esperienza trans, quando la stessa cultura clinica (come l’Oms) sta contemporaneamente riconfigurando la propria prospettiva in maniera non patologizzante. La notizia è passata come un fatto di cronaca ma non ha avuto grandi e profonde ripercussioni.
A parte l’effimero passaggio di Luxuria in Parlamento insieme a Rifondazione Comunista e ogni tanto qualche sparuto punto nei programmi elettorali, storicamente la sinistra non ha mai avuto grande attenzione politica per le questioni trans. Per la 164 dobbiamo ringraziare più i Radicali che il Partito Comunista, variamente omofobo (e poi anche vari giochetti della Dc).
Se la vetta più alta a cui la sinistra (leggi Pd) riesce a issarsi sono le unioni civili, e il top della transness mediatica sono Lili Elbe, Luxuria e Vittoria Schisano o, persino Platinette, non stupiamoci se i quotidiani parlano di noi in questo modo. I giornali sono un riflesso della cultura politica e la cultura politica italiana rimane elitaria, misogina, eterocisnormata e privilegiata.
Anche io, infine, da persona “informata sui fatti”, avendo oltretutto scritto un editoriale in merito su Gaynews, vorrei aggiungere qualcosa.
Apprezzo il tentativo del professor Lingiardi, mio relatore di laurea nel lontano 2004, e dei suoi colleghi di dirci che esiste una psicoanalisi “buona” contrapposta a una “cattiva”, che, purtroppo ha fatto danni e che continua a farne, ma il punto è un altro. Psicologici, psicanalisti, psicoterapeuti e psichiatri che portano nella relazione terapeutica i loro pregiudizi creano danni ai loro pazienti.
Una psicoanalisi che non accoglie le persone trans, che le giudica e le pre-giudica non solo non dovrebbe proprio esistere perché è l’anticamera delle teorie riparative, ma andrebbe combattuta dall’interno e dall’esterno, con tanto di richiesta di radiazione dagli albi di riferimento.
Avete diagnosticato e continuate a diagnosticare qualcosa che non può essere diagnosticato e diagnosticabile, perché la transessualità, il disturbo dell’identità di genere (Dig), la disforia di genere e l’incongruenza di genere non sono mai state un disagio mentale, come sta riaffermando l’Organizzazione mondiale della Sanità.
Gli effetti sulle persone trans, i disagi e le sofferenze, se ci sono e quando ci sono, derivano da una introiezione della transfobia, dalla transfobia interiorizzata che deriva indubbiamente dalla non accettazione e dalla condanna, spesso, sia famigliare sia sociale, dalla transfobia pervasiva vigente in tutti i contesti cis ed etero patriarcali. Se c’è qualcosa che ci causa sofferenza, si chiama pregiudizio e stigma.
Se c’è una ideologia si chiama psicoanalisi, le persone trans sono pratica millenaria dell’essere umano nelle sue declinazioni culturali, storiche, antropologiche e sociologiche. La strada, pur in salita, sta portando anche in Italia verso l’autodeterminazione, come a Malta, in Islanda, in Spagna, ma anche in Argentina, e presto in Danimarca, primo Paese ad aver depatologizzato in autonomia la “disforia di genere” nel 2015.
Prima o poi, sarete in molti a dover fare i conti con la storia. Siete ancora in tempo di decidere da che parte stare.